Discussioni 13
Discussioni #13
Luca Andreoni discute:
Carlo Poni,
Gli aratri e l’economia agraria nel Bolognese dal XVII al XIX secolo,
Zanichelli, Bologna 1963
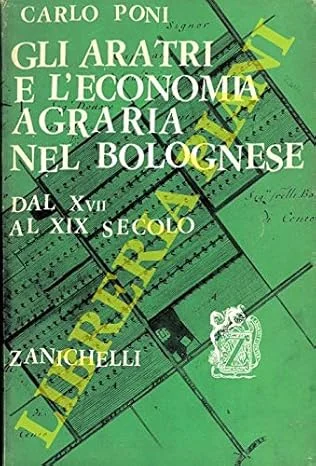
Il fascino dell’opera di Poni risiede, in primo luogo, nella capacità di restituire i meccanismi di connessione fra evoluzione delle tecniche e degli strumenti, innovazioni tecnologiche, forze sociali, performance economiche. Fascino precipuo di questo testo, Gli aratri e l’economia agraria nel Bolognese dal XVII al XIX secolo, pubblicato nel 1963; ma il discorso è estensibile a molti altri lavori dell’autore1. Evocare il meccanicismo non significa, però, tirare in ballo presunti automatismi nel procedere storico, ma piuttosto mettere in evidenza i nessi molteplici in diverse direzioni e i rapporti causali che si innescano, in particolare in termini di condizioni e conseguenze dell’adozione di specifiche tecniche di coltivazione. Quali rapporti sociali rendevano più facilmente utilizzabile una tecnica o un attrezzo? O, meglio, quali specifici contratti di conduzione e quali sistemi di distribuzione della terra e del lavoro offrivano le (o ostacolavano il raggiungimento delle) condizioni per la ricerca e l’adozione di vie alternative alla risoluzione di problemi colturali? O ancora, a valle, quale ruolo ebbe la scelta generalizzata di specifici strumenti e tecniche nell’evoluzione di un sistema agrario nel suo complesso e dunque anche nell’allocazione e nello sfruttamento del fattore lavoro? L’aver ricostruito, dalla prospettiva degli aratri utilizzati nel Bolognese (il piò, soprattutto, e l’arà), questo complesso di relazioni rimane un elemento di rilievo del libro, che aveva dei forti tratti di originalità e che ha mantenuto nel corso dei decenni un tratto di peculiarità2.
L’autore del libro era ben consapevole di muoversi in una sorta di terra incognita: già la storia delle tecniche non godeva di grande interesse nel contesto storiografico italiano, figurarsi lo studio delle tecniche nel loro encastrement sociale ed economico. Anche dopo le cose non andarono molto diversamente: sicuramente vi erano stati prima e vi sarebbero stati dopo il 1963 approfondimenti sugli attrezzi agricoli, ma difficilmente essi riuscirono a ricostruire il movimento d’insieme di tutto un mondo rurale come emerge dal lavoro di Poni. Da un lato l’archeologia rurale avrebbe sviluppato una riflessione fra manufatto, contesto e realtà sociale; dall’altro l’archeologia industriale, non a caso praticata dallo stesso Poni per la realizzazione di un museo a Bologna, avrebbe attinto in parte alla riflessione sulla cultura materiale3. Ma la storia dei manufatti era avviata a uscire progressivamente dall’alveo della storia economica. Un numero di «Quaderni storici» avrebbe fatto il punto sulla materia qualche anno dopo4.
Vi erano forse altre ragioni che contribuirono a rendere obliqua la ricezione del saggio di Poni, magistrale e in una certa misura irripetibile. Quello del 1963 può essere considerato un saggio di microstoria, avant la lettre, prima cioè del più celebre articolo Il nome e il come. Scambio ineguale e mercato storiografico scritto con Carlo Ginzburg e apparso nel 19795. Quell’articolo avrebbe poi contribuito ad animare una stagione di studi e di inquadramenti storiografici6. Questa sensibilità si coglie soprattutto nel rifiuto di «ogni arbitraria generalizzazione» o «fantasiose connessioni». L’eccezionalità delle condizioni della pianura bolognese e del caso ferrarese (gestione delle acque, tipologie dei terreni, forme di conduzioni prevalenti, disponibilità di forza lavoro e, su un altro piano, disponibilità di letteratura specifica - la grande stagione agronomica del Bolognese) rendevano peculiari quelle campagne e le economie sorte su quelle terre, così come quei paesaggi agrari e quegli strumenti per indagarli. Molto difficile, o meno scontato, esportare quel metodo di analisi (non solo i dati, ma anche le domande) in altri territori. En passant, lo specificò lo stesso Poni, in coda a una serrata e implacabile replica alla recensione con cui Emilio Sereni, tutto sommato, consacrò il volume7. Soprattutto, quando l’allargamento delle analisi avveniva per via estensiva su base geografica, la moltiplicazione dei casi di studio era catturata, da un lato, dai musei delle civiltà contadine e dagli studi minori connessi a quelle realtà, con intento essenzialmente descrittivo, dall’altro finì per favorire la moltiplicazione delle analisi a taglia ridotta, in un’ottica cumulativa che perse progressivamente di attrattività. Già Ruggiero Romano, che non aveva in simpatia l’approccio microstorico che di lì a poco avrebbe animato il già ricordato dibattito, pur riconoscendone alcuni pregi, scrivendo proprio a proposito di quel fascicolo di «Quaderni storici», affermò che «storia dell’abbigliamento, della cucina, degli attrezzi agricoli costituiscono oggetto della storia della cultura materiale: ma non credo che Levi Pisetzki, Poni, Camporesi, Faccioli (per non fare che dei nomi italiani) si considerino etnostorici»8. Implicitamente, quella di Poni era considerata un’indagine di storia della cultura materiale. Cosa effettivamente vera, ma la storia della cultura materiale era, per Poni, sempre veicolo per l’esplorazione delle campagne nel loro complesso o, meglio, del processo lavorativo in campagna. Gli oggetti, per Poni, permettono di giungere alle forze produttive. Così la comparazione fra «cose» porta alla comparazione fra sistemi agrari. Tale indirizzo di studio avrebbe trovato un risvolto pratico nella progettazione del museo di San Marino di Bentivoglio, secondo quanto scrisse lo stesso Poni, in quel medesimo fascicolo n. 31 di «Quaderni storici». La progressiva disaffezione verso la storia rurale, che avrebbe fatto diminuire la presenza di questo cantone storiografico nelle principali riviste di storia italiane, così come l’abbandono nel contesto storiografico successivo dell’architettura marxiana, che impregnava invece il lavoro di Poni, fecero il resto.
Luca Andreoni
Università Politecnica delle Marche
1In particolare “Misura contro misura: come il filo di seta divenne sottile e rotondo”, Quaderni storici, vol. 16, n. 47 (2), 1981, pp. 385-423.
2La sintesi e gli elementi di forza del testo sono stati recentemente ricostruiti da F. Cazzola, Dall’aratro al filo di seta: Carlo Poni, in A. Angelini, M. Beretta, G. Olmi (a cura di) Una scienza bolognese? Figure e percorsi nella storiografia della scienza, Bononia University Press, Bologna 2015, pp. 294-296, cui si rimanda per esigenza di brevità connessa a questo intervento
3D. Moreno, A.M. Stagno, L. Rossi, Archeologia industriale e le altre. Note per una storia della disciplina in Italia, in L’archeologia industriale in Italia. Storie e storiografia (1978-2008), a cura di A. Ciuffetti, R. Parisi, pp. 85-104.
4“Storia della cultura materiale”, Quaderni Storici, vol. 11, n. 31, 1976.
5C. Ginzburg e C. Poni, “Il nome e il come. Scambio ineguale e mercato storiografico”, Quaderni Storici, vol. 14, n. 40, 1979, pp. 181–90.
6Carlo Ginzburg ha rievocato il contesto in cui nacque quel contributo in “Ricordando Carlo Poni. Una rilettura de «Il nome e il come»”, in Quaderni storici, n. 161, 2019, pp. 552-556.
7C. Poni, “Aratri e sistemazioni idrauliche nella storia dell’agricoltura bolognese”, Studi Storici, vol. 5, n. 4, 1964 p. 673, mentre si veda p. 634 per la citazione precedente.
8R. Romano, “Ruggiero Romano interviene su etnostoria e cultura materiale”, Quaderni storici, n. 32, 1976, p. 865; Romano criticava l’utilizzo del concetto di etnostoria formulato dai curatori del fascicolo evocato, Diego Moreno e Massimo Quaini.
