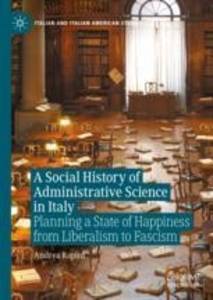Discussioni #10
Pietro Costa e Guido Melis discutono:
Andrea Rapini,
A Social History of Administrative Science in Italy. Planning a State of Happiness from Liberalism to Fascism,
Palgrave Macmillan, London 2022
Come citarci: P. Costa e G. Melis A Social History of Administrative Science in Italy. Planning a State of Happiness from Liberalism to Fascism di Andrea Rapini, Sito della Società Italiana di Storia del Lavoro, 14 luglio 2023, www.storialavoro.it/discussioni-10/
Il libro di Andrea Rapini è dedicato a un problema interessante: la nascita e il declino di una disciplina – la Scienza dell’amministrazione – nell’Italia otto-novecentesca (mentre resta fuori dal perimetro dell’indagine la ‘rinascita’ di quella disciplina nel secondo Dopoguerra).
Fare oggetto di indagine storiografica una ‘disciplina’ è una scelta impegnativa e relativamente rara, mentre più frequenti sono le ricerche dedicate alla ricostruzione della ‘biografia intellettuale’ dell’uno o dell’altro autore oppure alla ricognizione di un tema specifico. Per quanto difficile, l’opzione di concentrare l’attenzione sulla ‘disciplina’ come tale è indubbiamente allettante, nella misura in cui promette, da un lato di individuare gli elementi che, in un determinato contesto storico, delimitano e caratterizzano un sapere ‘specialistico’ e, dall’altro, di cogliere i punti di contatto e le reciproche ‘contaminazioni’ che intercorrono fra quel sapere e la cultura complessiva.
Il libro di Rapini merita di essere letto già soltanto perché richiama l’attenzione su una così interessante e sfuggente area di indagine. I problemi che esso solleva sono numerosi e importanti e dovrebbero essere discussi a fondo. Manca però lo spazio per un’analisi esauriente e dovrò limitarmi a rapide e superficiali considerazioni.
Conviene chiedersi, preliminarmente, quali siano i concetti metastoriografici impiegabili per individuare, nell’immane congerie di discorsi circolanti in un determinato contesto storico, un corpus testuale che, in quel contesto, viene presentato e legittimato come un discorso cognitivamente ‘forte’, latore di un ‘sapere’ capace di ‘dire la verità’ su un determinato profilo della realtà: appunto, una ‘disciplina’.
Come descrivere gli elementi che contribuiscono a rendere relativamente unitario un determinato sapere specialistico? Andrea Rapini usa cursoriamente il termine ‘nomos’, definendolo come «the fundamental principles of vision and division considered scientific» (p. 111), come «the method, the subject, the direction, the criteria of truth» (p. 124) dominante in una disciplina.
Non sono sicuro che questo termine sia lo strumento metalinguistico (metastoriografico) più preciso e idoneo. A me sembra preferibile il concetto (kuhniano) di paradigma. Il paradigma, in sintesi, è l’insieme degli elementi che permettono a un determinato sapere di elaborare un’originale rappresentazione del proprio oggetto e di adottare uno schema condiviso di rappresentazione, di ‘modellizzazione’, della realtà. Il paradigma, così inteso, è circolarmente connesso con una ‘comunità scientifica’. «A paradigm – scrive Kuhn – is what the members of a scientific community, and they alone, share. Conversely, it is their possession of a common paradigm that constitutes a scientific community of a group of otherwise disparate men»1.
Il paradigma, dunque, da un lato, coincide con le strategie discorsive che offrono una peculiare rappresentazione, ‘modellizzazione’, della realtà, e, dall'altro lato, riposa sul consenso della comunità disciplinare, che in quello schema si riconosce. La ‘modellizzazione’ della realtà – la prestazione caratteristica di un determinato sapere – è quindi inseparabile dalla strutturazione del gruppo sociale (la ‘comunità scientifica’) che da quel sapere trae la propria identità e funzione sociale. La storia di una ‘teoria’, nella misura in cui diviene storia di uno specifico ‘sapere disciplinare’, non può non prendere in considerazione il rapporto che intercorre fra la ‘comunità disciplinare’ e il sapere da essa prodotto e deve altresì tentare di decifrare gli effetti ‘performativi’, socialmente e politicamente rilevanti, del ‘paradigma’2.
A me sembra che il libro di Andrea Rapini si muova entro queste coordinate e tragga la sua rilevanza e originalità dal concentrare la sua attenzione, prima, sulla comunità (o sub-comunità) disciplinare cui è riferibile la Scienza dell'amministrazione, e, poi, sulle prestazioni cognitive e performative di quel sapere.
Conviene sottolineare l'importanza e l'originalità di un'analisi dedicata a ricostruire la logica interna di una ‘comunità disciplinare’, i rapporti e i conflitti di potere che la innervano, le posizioni (di dominanza o di subalternità) che rivestono i suoi membri. Per portare avanti una siffatta analisi occorre ovviamente situare la ‘comunità disciplinare’ nel contesto storico-istituzionale nel quale essa concretamente ha operato: le istituzioni universitarie del giovane Stato italiano (e a questo proposito Rapini ci ricorda l'alternativa fra il ‘modello germanico’, incline a valorizzare l'autonomia dell’università, e il ‘modello francese’, di ispirazione centralistica, e sottolinea la forte incidenza del vertice ministeriale nella conduzione delle università italiane).
È in questa cornice, correttamente delineata, che Rapini colloca la sua analisi dei rapporti di potere soggiacenti alla strutturazione della disciplina ‘amministrativistica’. Come ricostruirli? Studiando la distribuzione dei ruoli accademici, individuando i criteri di assunzione dei docenti, enumerando i vincitori e gli sconfitti, esaminando i criteri che presiedevano alla cooptazione o all'esclusione, alla valorizzazione o alla marginalizzazione dell’uno o dell’altro membro della ‘comunità’.
Quali siano le fonti che permettono di ricostruire dall'interno questa vicenda è facilmente intuibile: gli atti dei concorsi universitari, i lavori delle commissioni, i giudizi dei commissari, il confronto fra i concorrenti. Queste fonti sono indispensabili per mettere a fuoco – come scrive Rapini – le relazioni potestative all’interno della comunità disciplinare (p. 8) e una loro accurata descrizione sarebbe già un’utile acquisizione. Il nostro autore però non si limita a un’elencazione e a una descrizione, ma si impegna con successo in un’elaborazione che ricorre agli strumenti della Social Network Analysis per riorganizzare i dati quantitativi in modo da mettere a fuoco la rete dei rapporti interni al ‘gruppo professionale’ e offrirne una trasparente rappresentazione grafica3.
A mio avviso, la scelta di soffermarsi sulla strutturazione della ‘comunità disciplinare’, la scrupolosa raccolta di dati, l’individuazione di uno strumento metodologico efficace nella loro elaborazione e la sua limpida applicazione sono il tratto più originale e convincente del libro di Rapini e bastano, da soli, a mostrarne l’importanza.
L’analisi, certo, non può arrestarsi a questo livello: a conferma che il ‘paradigma’ (o ‘matrice disciplinare’) è una realtà a due facce, Rapini infatti non si limita a individuare ‘chi comanda’ e ‘chi obbedisce’, a indicare quali membri siano relegati alla ‘periferia’ e quali occupino il ‘centro’ della ‘comunità scientifica’, ma si interroga anche sulla ‘costruzione’ dell’oggetto e sulle strategie di ‘rappresentazione’ (di ‘modellizzazione’) della realtà che conferiscono alla Scienza dell’amministrazione la sua peculiare identità.
Rapini delinea la parabola disciplinare della Scienza dell’amministrazione: una parabola ascendente, a partire dalla fondazione dello Stato unitario, e poi declinante nell’Italia del primo dopoguerra, fino al suo formale (anche se provvisorio) esaurimento, nel 1935, su decisione del ministro De Vecchi. La ricostruzione delineata da Rapini è limpida ed esaustiva e offre informazioni interessanti su una componente, nota ma spesso trascurata, della giuspubblicistica italiana otto-novecentesca, senza mai perdere di vista lo stretto rapporto che intercorre fra la formulazione di un enunciato ‘dottrinale’ e il contesto storico-politico nel quale esso prende forma, funziona concretamente, produce effetti praticamente rilevanti.
I macrofenomeni cui Rapini collega la vicenda da lui studiata sono due: da un lato, la costruzione (e poi il rafforzamento e la legittimazione) del nuovo Stato unitario e, dall’altro lato, l’urgenza di far fronte a un conflitto sociale che minacciava di mettere a repentaglio la tenuta dell’ordine socioeconomico complessivo e suggeriva alle classi dirigenti l’opportunità di attribuire allo Stato l’onere non soltanto della repressione, ma anche dell’integrazione delle masse.
In tutta Europa si moltiplicavano, fra Otto e Novecento, proposte che, pur diverse fra loro, convergevano nel prendere la distanza dalla ‘classica’ tradizione giusliberale per reclamare la necessità di un coinvolgimento attivo e diretto dello Stato nel governo della società, nella gestione dei bisogni vitali dei soggetti. Una nuova sensibilità investe diversi saperi specialistici (dall’economia al diritto, alla sociologia) e reclama il superamento dell’‘individualismo’ in nome della ‘solidarietà’: la società è pensata non più come una somma di azioni e interessi individuali, ma come un ‘organismo’ tenuto insieme dalla stretta interazione delle più diverse formazioni sociali.
Di questa rete di rapporti ‘solidali’ lo Stato è parte integrante e tramite indispensabile. Occorre quindi ripensare il rapporto fra lo Stato e la società individuando le forme e gli strumenti del suo indispensabile ‘interventismo’: è questo il compito che la Scienza dell’amministrazione intende assumersi accogliendo e riformulando la proposta e il metodo elaborati da un autore tedesco che correttamente Rapini indica come l’indispensabile punto di riferimento della Scienza dell’amministrazione italiana: Lorenz von Stein.
È da Stein (noto in Italia e anche insignito, come ricorda Rapini, di una laurea honoris causa nell’università di Bologna) che proviene l’input determinante per il decollo della Scienza dell’amministrazione in Italia. È indubbio quindi il nesso, sottolineato da Rapini, fra il ‘programma’ della nuova disciplina e l’esigenza di ripensare le finalità e la strumentazione delle istituzioni di governo. Conviene però, al contempo, collocare l’analisi del caso di specie – la Scienza dell’amministrazione – all’interno della complessiva testualità giuspubblicistica.
Il campo teorico giuspubblicistico si veniva strutturando intorno al rapporto ‘Stato-società’ e alle diverse e confliggenti rappresentazioni che di questo rapporto venivano proposte. Queste rappresentazioni erano molto diverse, ma possono essere ricondotte a precise ‘modellizzazioni’ sulle quali è impossibile diffondersi in questa sede. Mi limito a ricordare una summa divisio: fra modelli (che chiamo) ‘sociocentrici’ e ‘statocentrici’4.
Nella modellizzazione ‘sociocentrica’ il referente primario è la ‘società’ ed è alla luce delle sue caratteristiche strutturali che viene rappresentato il rapporto Stato-società e viene sottolineato il ruolo socialmente essenziale dello Stato. La Scienza dell’amministrazione, nella prima fase della sua parabola, adotta questa prospettiva, ma non ne detiene l’esclusiva: non mancano infatti giuristi a essa estranei impegnati a sostenere una rappresentazione ‘sociocentrica’ del rapporto Stato-società.
Nella modellizzazione ‘statocentrica’ (promossa da Vittorio Emanuele Orlando) è invece proprio la ‘società’ a scomparire per essere sostituita dal ‘popolo’ (o ‘nazione’): l’analisi dei rapporti e dei conflitti sociali cessa di essere giuridicamente rilevante e al suo posto compare un’entità ‘organicamente’ unitaria – il ‘popolo’ o ‘nazione’ – che deve essere considerata «come equivalent[e], in sostanza, della parola ‘Stato’ […]»5.
Il modello ‘statocentrico’, nella versione orlandiana, diviene l’assetto (che Kuhn chiamerebbe) ‘normale’ del sapere giuspubblicistico. Ne offre una riprova eloquente l’attenta ricostruzione che Andrea Rapini ci offre della seconda fase della Scienza dell’amministrazione, mostrando come la forza persuasiva della prospettiva orlandiana (e l’abile orchestrazione delle commissioni concorsuali) trasformino la disciplina e conducano alla sostanziale emarginazione dell’approccio ‘sociocentrico’.
Il principale artefice di questa trasformazione è, per Rapini, Oreste Ranelletti, che diviene il vero dominus di quel settore disciplinare. Rapini lo presenta come il custode del (nuovo) ‘nomos’: potremmo anche dire, giocando sul termine, l’artefice della ‘normalizzazione’ della disciplina, il curatore fallimentare incaricato della liquidazione del vecchio patrimonio ‘sociocentrico’ (salvo qualche suo timido ripensamento post festum, puntualmente segnalato nel nostro libro). È una diagnosi condivisibile, cui aggiungere uno scolio (peraltro ovvio): la vittoria del ‘metodo giuridico’ nella Scienza dell’amministrazione era la rifrazione ‘locale’ del successo di cui esso godeva nell’intero sapere giuspubblicistico.
Il mutamento di paradigma all’interno della Scienza dell’amministrazione (e in generale il successo del modello ‘statocentrico’ orlandiano nel sapere giuspubblicistico) non implica però l’interruzione di qualsiasi rapporto fra la Scienza dell’amministrazione (e il sapere giuspubblicistico nel suo complesso) e quello ‘Stato sociale’ che cominciava a essere insistentemente raccomandato fra Otto e Novecento. Se così fosse, fra la costruzione dello Stato sociale (che, pur faticosamente e contraddittoriamente, procede in tutta la prima metà del Novecento) e la coeva giuspubblicistica (‘paradigmaticamente’ orlandiana) non sarebbero esistiti punti di contatto e reciproci coinvolgimenti. Non è così, però, proprio a causa delle caratteristiche peculiari della prospettiva orlandiana.
È vero, infatti, che la Scienza dell’amministrazione (nella sua fase ‘sociocentrica’) è solidale con le prime progettazioni dello ‘Stato sociale’ ed è incompatibile con gli assiomi del primo liberalismo. Questi assiomi però, se vengono ancora accolti dalla giuspubblicistica ottocentesca in alcuni modelli ‘dualistici’, vengono espunti dal monismo statocentrico orlandiano, che si lascia alle spalle il ‘dualismo’ tipico del costituzionalismo liberale, risolve il ‘popolo’ (o ‘nazione’) nello Stato e attribuisce a esso un compito giuridicamente ‘ordinante’ che non è sostantivamente predeterminato, non è vincolato a specifici contenuti, e può quindi tranquillamente dar forma giuridica anche a una politica socialmente interventista. Valga a riprova la posizione di Ranelletti: che può ‘normalizzare’ la Scienza dell’amministrazione (imponendo a essa il rispetto del ‘metodo giuridico’ e distogliendola dal suo originario alveo ‘dualistico’ e sociologistico), ma può al contempo spezzare una lancia a favore dello ‘Stato sociale’, investito del compito di «prevenire le miserie materiali e morali delle classi inferiori»6.
Una Scienza dell’amministrazione che, a partire dal primo dopoguerra, va incontro a un crescente allineamento alle parole d’ordine della Scuola orlandiana, pone allo storico un problema rilevante, che Rapini non manca di affrontare: il rapporto con il regime fascista e con il suo apparato ideologico.
Il problema è complicato perché è inseparabile dal dibattito che, nel corso del ventennio fascista, investe il problema del rapporto del fascismo con la storia d’Italia, in generale, e, in particolare, con la tradizione giuridica nazionale. Devo semplificare brutalmente i termini del dibattito: da un lato, i difensori del fascismo come culmine e ‘compimento’ della storia statual-nazionale italiana; dal lato opposto, i sostenitori del fascismo come ‘rivoluzione’, come drastico congedo dalla ‘vecchia Italia’; da un lato, i giuristi ‘tradizionalisti’, che sostenevano la spontanea congruenza della modellistica statocentrico e giuridico-formalistica con le strategie politiche del regime, dal lato opposto, i giuristi (fascisticamente) ‘militanti’, che reclamavano una aperta ‘fascistizzazione’ – una compiuta sovradeterminazione politica – dei principali concetti giuspubblicistici.
Il dibattito è vivace ed essenzialmente interno al regime (e connesso con i conflitti di potere che lo percorrono). Certo, non manca chi (come, emblematicamente, Calamandrei) confida (illusoriamente) che la difesa del ‘puro’ diritto possa essere un atto di ‘nicodemica’ presa di distanza dal regime. In realtà, al di là delle ‘soggettive’ intenzioni e aspettative di alcuni, ‘oggettivamente’ il sistema politico-giuridico fascista funziona proprio grazie alla reciproca implicazione, alla connessione ‘sistemica’, fra ‘decisione’ e ‘norma’, fra ‘politica’ e ‘diritto’, fra tradizione ‘statocentrica’ e istanze di ‘rivoluzionaria’ fascistizzazione dello Stato7.
Se ciò è vero, è facile comprendere come la Scienza dell’amministrazione, ‘normalizzata’ intorno alla condivisione del paradigma statocentrico e giuridico-formalistico (la Scienza dell’amministrazione secondo Ranelletti, per intenderci), fosse, da un lato, tranquillamente compatibile con le strategie del regime, ma, dall’altro lato, fosse esposta al rischio della perdita della propria specificità disciplinare. Né potremmo attenderci che ad opporsi alla ‘normalizzazione’ ranellettiana fossero i giuristi (fascisticamente) ‘militanti’: che non provavano alcuna nostalgia nei confronti dei tanti solidarismi tardo-ottocenteschi (che erano il terreno di coltura della Scienza dell’amministrazione nella sua fase ‘originaria’) e reclamavano piuttosto una più aperta ‘politicizzazione’ del sapere giuridico. La ‘vecchia’ Scienza dell’amministrazione era ormai improponibile e la nuova era, nella migliore delle ipotesi, superflua. La sua dissoluzione – puntualmente ricostruita da Andrea Rapini – era ormai segnata.
Sarebbe interessante ricordare i singoli passaggi della parabola discendente della disciplina, ma devo semplicemente rinviare all’accurata analisi offerta dal nostro libro e limitarmi, conclusivamente, a confermarne la rilevanza: non soltanto per le interessanti e documentate considerazioni sul dibattito politico giuridico otto-novecentesco, ma anche e soprattutto per l’adozione di un’originale strategia metodologica che ha favorito l’accurata ricostruzione storico-sociologica di un appartato, ma culturalmente significativo, ‘sapere specialistico’.
Pietro Costa
Professore emerito in Storia del diritto medievale e moderno
Università degli Studi di Firenze
La scienza dell’amministrazione in Italia assomiglia a Moby Dick. Compare nel secondo decennio postunitario, forte degli studi di Manna e Messedaglia; e viene recepita nel regolamento universitario del 1875 emanato dal ministro Ruggiero Bonghi sia pure ancora come insegnamento facoltativo nelle facoltà di giurisprudenza. I suoi contenuti appaiono in quei primi esordi piuttosto come una variante del pur esso nascente ma già consolidato diritto amministrativo, quasi una esposizione in appendice delle pratiche delle amministrazioni, dove viceversa l’altra disciplina, più consolidata, coltivava ambizioni teoriche.
Nel 1885 il ministro Coppino (frattanto era avvenuto il passaggio dalla Destra storica alla Sinistra) unisce formalmente la scienza dell’amministrazione in una sola diadi col diritto amministrativo. Dietro di sé, la materia ha adesso un più che apprezzabile albero genealogico: da Giandomenico Romagnosi, il fondatore secondo alcuni del diritto amministrativo in Italia, a Giovanni Manna; da Federico Persico ad Angelo Messedaglia. Sullo sfondo – in un’epoca storica nella quale i giuristi italiani passavano dall’egemonia degli studi francesi alla fascinazione per quelli tedeschi, su tutti sovrastava l’insegnamento di Lorenz von Stein. Poi vennero Wautrain Cavagnari, Carlo Francesco Ferraris, Attilio Brunialti (che tradusse Stein nella sua Biblioteca di scienze sociali),più tardi ancora Luigi Rava, cui Rapini dedica (ed è uno dei tanti pregi innovativi del suo libro) pagine assai interessanti.
Occorre subito dire – come del resto fa l’autore di questo bel libro – che questi pur diversi interpreti della nascente scienza amministrativa erano spinti da un movente pratico comune: essi erano, ognuno a suo modo, partecipi di quel processo di nation building che caratterizzò l’amministrazione italiana nel periodo tra la formazione del nuovo Stato e grosso modo la fine dell’Ottocento. Un’amministrazione nella quale giocavano ancora un ruolo decisivo i saperi tecnici, essendo – nonostante i conclamati principi liberisti dei fondatori dell’Italia unita – lo Stato impegnato giocoforza in una intensa attività di “supplenza” delle risorse private e in un formidabile sforzo di regolazione dall’alto della società. Dietro i teorici che ho sommariamente citato, spesso ad essi mescolati, c’erano dunque i “pratici”: una intensa produzione di letteratura specifica, spesso come s’usa dire “grigia”, nata dalle attività delle varie amministrazioni. Ne furono un prodotto tipico i Manuali Hoepli o altre simili edizioni “popolari” cui si dovette l’acculturazione di una burocrazia statu nascenti priva per lo più di studi e di lauree, addestratasi per così dire nella pratica degli uffici.
I “tecnici”, come pure furono chiamati, tenevano dunque campo al fronte dei “giuristi”: ingegneri dello Stato (la pépinière fu il Genio civile, soprattutto), architetti, attuari, statistici, esperti in pesi e misure, ufficiali del catasto, ragionieri dal titolo di studio ancora incerto, esperti d’acque e bonifiche idrauliche… La lista potrebbe continuare a lungo. Sino alla fine del secolo XIX l’amministrazione italiana fu di dimensioni limitate ma fu al tempo stesso ricca di queste varie professionalità. La scienza dell’amministrazione poggiava su una solida base: una specie di grande deposito di saperi pratici.
Tutto cambiò, ci dice Rapini, quando sopravvenne la “rivoluzione”, cioè l’avvento della scuola orlandiana di diritto pubblico. Vittorio Emanuele Orlando (che diede il nome a quel balzo in avanti e alla lunga filiera di giuristi di seconda generazione che ne derivò) ne fu il leader indiscusso, anche per il ruolo che ebbe frattanto nella politica di Giolitti e poi soprattutto nel periodo della guerra mondiale (fu nel 1918 “il presidente della Vittoria”). Ranelletti, Cammeo ne furono i continuatori, soprattutto Santi Romano ne fu l’eccezionale allievo. Nel 1912 proprio Romano avrebbe negato alla scienza dell’amministrazione “un contenuto proprio ed esclusivo” ed avrebbe sostenuto potersi quella disciplina “soltanto concepire come l’insieme delle varie scienze che toccano l’amministrazione pubblica”. Dunque un mero agglomerato di saperi “minori”, umili, uniti dalla loro stessa eterogeneità, totalmente mancanti di basi teoriche, puramente descrittivi e quindi al di fuori della speculazione giuridica propria, per esempio, del diritto amministrativo.
Il quale diritto amministrativo conobbe nel periodo giolittiano la sua età dell’oro, espressa specialmente nelle opere dei maestri citati e dei loro allievi diretti. Come documentò molti anni fa Cesare Mozzarelli lavorando sui bollettini ministeriali, non vi fu più concorso universitario nel campo giuspubblicistico che non sancisse la irresistibile escalation degli “orlandiani”, che non fosse direttamente controllato da Orlando e dai suoi; la stessa amministrazione pubblica, emarginati rapidamente al suo interno i “tecnici” (bastò imporre la laurea in giurisprudenza come conditio sine qua non per accedere alla dirigenza), divenne un corpo burocratico formato eminentemente di giuristi (o sarebbe meglio dire, a evitare equivoci, di conoscitori delle norme).
Della vicenda che ho qui sommariamente ripercorso, che potremmo descrivere come l’irresistibile ascesa e inesorabile declino della scienza dell’amministrazione, Andrea Rapini documenta con grande perizia e acume tutti i passaggi essenziali, dando conto di momenti clou, personalità, libri e saggi, farsi e disfarsi di scuole accademiche, contatti personali con lo Stato. Egli può – certo – lavorare su una storiografia ormai consolidata: ho già citato Mozzarelli, aggiungerò il suo sodale Stefano Nespor (autori entrambi di Giuristi e scienze sociali nell’Italia liberale), poi Giorgio Rebuffa su La formazione del diritto amministrativo in Italia, poi ancora Massimo M. Augello, per essersi occupato – coi suoi allievi – dell’espulsione dall’amministrazione degli economisti; e Francesca Sofia, Marco Meriggi, e forse – se posso – i miei stessi studi, specie la Storia dell’amministrazione italiana; storiografia culminata infine nel Trattato di diritto amministrativo diretto da Sabino Cassese nel quale molti echi si potrebbero trovare della vicenda della scienza dell’amministrazione.
Dietro questo intenso e pluridecennale lavoro storiografico (se ne trovano tutte le tracce necessarie nelle note del libro di Rapini), campeggiavano già allora le folgoranti intuizioni risalenti agli ultimi anni Trenta, di Massimo Severo Giannini, che ebbe il merito di riscattare precocemente le discipline non strettamente giuridiche dalla damnatio cui le aveva condannate l’avvento dell’orlandismo (e con esso del positivismo giuridico quale base della formazione monocorde del giurista).
Cessata la fase per così dire “di emersione”, Moby Dick (alias la scienza dell’amministrazione) si inabissò e per lunghi decenni si nascose nelle profondità inesplorate dell’oceano della cultura delle istituzioni. Il fascismo cambiò ben poco (Rapini ne parla diffusamente, seguendo il mesto declino – che fu forse meno repentino di come qui io lo abbia evocato – della disciplina e dei suoi seguaci sino alla definitiva cancellazione della materia dai curricula universitari ad opera di De Vecchi). I conti del resto erano stati già saldati precocemente, nei primi anni Venti, quando qualcuno aveva sperato invano che il nuovo regime modificasse o addirittura invertisse la tendenza: erano di moda allora (ma fu una moda effimera) i cosiddetti “tayloristi della scrivania”, che auspicavano l’adozione del metodo del lavoro industriale Taylor per riorganizzare l’intera amministrazione con iniezioni di forti saperi esterni. Rivoluzione vagheggiata, ma inesorabilmente fallita. Né valsero a riproporre la scienza dell’amministrazione i venti benevoli provenienti dall’America del dopoguerra. La ripresa – Rapini qui non ne parla, essendo il suo libro delimitato al primo fascismo – sarebbe avvenuta molto dopo, negli anni Sessanta e seguenti, ma su basi tutt’affatto diverse. Perché adesso, nell’Italia del post-miracolo, la scienza dell’amministrazione avrebbe assunto altre forme e fatto riferimento ad altri universi culturali: la sociologia (gli studi sulle burocrazie introdotti in Italia dalle edizioni del Mulino), il volume-guida di Michel Crozier (che apparso in Francia nel 1963 fu tradotto in Italia nel ’68 sotto il titolo Il fenomeno burocratico), gli studi pionieristici promossi da Giorgio Freddi e dalla sua scuola bolognese; e poi Ferraresi e Spreafico, autori tra l’alto di un importante volume antologico; e per quanto concerne l’amministrazione specialmente Alessandro Taradel e la sua “Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione”. Sabino Cassese, nel classico studio del 1971 (Cultura e politica del diritto amministrativo: un libro che al suo apparire fece scandalo tra i “conservatori”) e poi soprattutto in un importante saggio su “Foro italiano” del 1992 (Lo smarrimento di Oreste e la furia delle Eumenidi: la vicenda intellettuale della scienza dell’amministrazione)avrebbe sapientemente “fotografato” quel momento di ripresa, che ebbe certo un riflesso sugli studi prettamente giuridici, ma tardò a tradursi in influenza culturale a vasto raggio e soprattutto a consolidarsi accademicamente dentro le università.
Quando finalmente ciò avvenne, diversi anni dopo, la scienza dell’amministrazione aveva per così dire mutato pelle: era ormai divenuta una branca della politologia, assai distante dalla ispirazione giuridica dei suoi padri fondatori ottocenteschi. Di questa abbastanza radicale trasformazione ci parlerà forse un prossimo libro di Andrea Rapini, che potrebbe costituire il seguito di questo, chiuso nella soppressione da parte di De Vecchi.
In questo volume però, intanto, il lettore troverà non solo la ricostruzione puntuale di una storia poco nota, ma specialmente lo spunto implicito per una riflessione. Cosa sarebbe accaduto – viene da domandarsi – se l’Italietta postunitaria avesse potuto proseguire nel suo laborioso sforzo di unire tra loro saperi, esperienze pratiche, progettualità, modelli organizzativi pluralistici? Se cioè non fosse intervenuta precocemente la scure pesante della “normalizzazione” orlandiana? Non è questo il tema centrale del libro, e forse Rapini non si porrebbe negli stessi termini la domanda che ho appena formulato. Del resto l’altezza teorica e la capacità egemonica raggiunta dalla scuola italiana di diritto pubblico è fuori discussione e poco varrebbe confrontarla con l’alternativa rappresentata dai precursori, cui non a caso è stato apposta la denominazione implicitamente riduttiva di “preorlandiani”. L’Italia tuttavia – come documentò Giulio Cianferotti – conobbe nel passaggio tra Otto e Novecento una vera escalation ai vertici del potere dei giuristi positivi in quanto ceto sociale (provenivano per lo più tutti non solo dalla borghesia ma dalle file dell’accademia universitaria). È singolare (e non so quanto se ne possa trovare corrispondenza nella storia degli altri Paesi) che la prima rivoluzione industriale, la nascita della fabbrica moderna, la ristrutturazione del territorio che ne derivò, insomma la prima fuoruscita del Paese dagli angusti confini che avevano caratterizzato i quattro ultimi decenni dell’Ottocento, avvenissero sotto la guida di una classe dirigente (specie quella politico-parlamentare) in larga misura formata di giuristi e specificamente di giuristi forgiati dalla “rivoluzione orlandiana”. Implicitamente Rapini, con questa sua ricerca, ci dice che potevamo ereditare dal primo Novecento uno Stato e un Paese diversi, ma non li abbiamo avuti.
Guido Melis
Professore emerito di Storia delle istituzioni politiche
Sapienza Universita' di Roma
1Th. S. Kuhn, Second Thoughts on Paradigms, in Id., The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change, University of Chicago Press, Chicago 1977, p. 294.
2Per una più accurata esplicitazione di questi passaggi mi permetto di rinviare a P. Costa, Histoire, théorie et histoire de théories, in C. M. Herrera, A. Le Pillouer (a cura di), Comment écrit-on l’histoire constitutionnelle?, Kimé, Paris 2012, pp. 19-56.
3Cfr. anche A. Rapini, E. Pavan, Reti, poteri e confini nelle ‘discipline amministrativistiche’ italiane (1885-1935): per una storia sociale delle idee, in «Italia contemporanea», 299 (2022), pp. 19-48.
4Per una descrizione analitica dei ‘modelli’ messi a punto dalla giuspubblicistica italiana mi permetto di rinviare a P. Costa, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, Giuffrè, Milano 1986.
5V.E. Orlando, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica (1895), ora in Id., Diritto pubblico generale, Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema, Giuffrè, Milano 1940, p. 440.
6O. Ranelletti, Concetto e contenuto giuridico della libertà civile, in «Annali della R. Università di Macerata, II (1927), p. 13.
7Mi permetto di rinviare a P. Costa, Il regime fascista fra ‘diritto’ e ‘politica’: un caso di «dual State»?, in «Giornale di storia costituzionale», 43 (2002), 1, pp. 93-118.