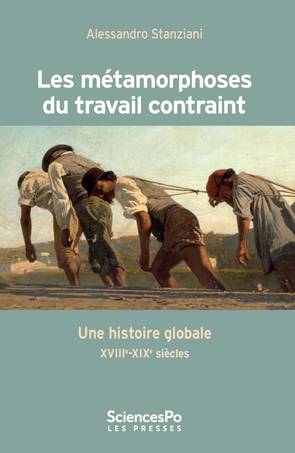Discussioni #6
Martino Sacchi Landriani e Maria Luisa Pesante discutono:
Alessandro Stanziani,
Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale XVIIe-XIXe siècles,
Paris, Presses de Sciences Po, 2020
La traiettoria biografica di un Joseph Conrad marinaio – ancor prima che scrittore – accompagna il lettore de Les métamorphoses du travail contraint (Presses de Sciences Po, 2020, pp. 328) fin dalle prime pagine. Il suo viaggio attraversa un mondo di frontiere mobili tra libertà e coercizione, che il libro indaga con accuratezza storica, culminando in una riflessione conclusiva sull’esperienza stessa dell’archivio (pp. 317-325). Ad ogni tappa, l’attenzione si rivolge tanto alle concettualizzazioni svolte dagli attori storici quanto alla discussione critica dei modelli interpretativi : una combinazione di sguardi tesa a mettere in luce le rilevanze epistemologiche della ricerca anche al di là dei singoli casi di studio. In questo senso, il testo partecipa di una più ampia riflessione dell’autore sulle metodologie storiografiche tese a superare i perimetri storiografici nazionali o di area[1]. L’ambizione centrale è quella di riunire in un’unica prospettiva la storia del lavoro salariato e quella della schiavitù e della sua abolizione. Se lavoro libero e coatto “compongono una sola e medesima storia” (p. 8) si pone dunque il problema di rintracciare tanto le circolazioni quanto le asimmetrie, tanto la comunanza di problematiche quanto le specificità locali in cui esse si inseriscono.
Per farlo, Stanziani propone un percorso a ritmo serrato, in cui l’analisi mirata di fonti archivistiche si inserisce in una vasta bibliografia secondaria per ogni territorio e periodo preso in considerazione. E’ un libro molto denso, nel quale si articolano più livelli di analisi volti a problematizzare il binarismo libertà-coercizione. Tra questi, potremmo isolare almeno tre angoli prospettici: il tema della categorizzazione, il controllo della mobilità del lavoro, l’evoluzione e circolazione delle forme contrattuali.
In primo luogo, il libro dedica spazio alle forme del lavoro in quanto costruzioni discorsive interconnesse. Ne emerge ciò che potremmo definire, per riprendere il titolo del primo capitolo, un gioco di “specchi”. Ad esempio, attraverso l’esperienza russa dei fratelli Bentham il servaggio è considerato non solo nelle sue specificità locali ma anche come costruzione interna a un dibattito sulle controversie del lavoro salariato in Inghilterra (pp.17-31). Oppure, attraverso Henri Sumner Maine l’introduzione del Master and Servants in India viene collegata all’abolizione delle sanzioni penali per i lavoratori britannici (pp. 256-261). Appaiono così in filigrana le operazioni di gerarchizzazione inerenti al discorso civilizzatore, che Stanziani riconduce poi all’interno di contesti e funzionamenti specifici. Ad esempio, la definizione delle tipologie contrattuali ottocentesche in Francia (in un periodo in cui contratti erano spesso orali e mescolavano clausole inerenti a diversi tipi di locazione di lavoro) viene mobilitata strategicamente nei tribunali a seconda degli interessi degli attori (p.114 e ss.). Analogamente, i processi di affrancamento dal servaggio implicano “operazioni di qualificazione e riqualificazione sociale” sulla definizione di nobiltà (pp. 37-42); o ancora la definizione del lavoratore marittimo come operaio comporta il tema dell’allargamento di determinate protezioni (pp. 81-84). L’universalità di categorie propria dei dibattiti nel movimento abolizionista viene confrontata con processi concreti di emancipazione a Mauritius e Réunion (capitoli 4 e 5). Per altro verso, questa analisi delle argomentazioni da parte degli attori storici costituisce un punto di entrata per confrontarsi poi con i risultati della ricerca di storia economica : l’impatto della Guerra di Secessione sul mercato internazionale del cotone (pp. 249-251), la lentezza del processo di unificazione del mercato del lavoro in Francia (pp. 261-262), o ancora l’impiego delle corvée in Russia (p.43-45). In ogni caso, tra gli apporti della ricerca di Stanziani possiamo sottolineare la tensione a considerare il materiale d’archivio non solamente come traccia del reale, ma anche come una modalità organizzativa della conoscenza che contribuisce a forgiare le esperienze storiche.
In secondo luogo, il libro affronta le categorie del lavoro all’interno di regimi complessi, che coniugano le asimmetrie contrattuali ad altre forme di dipendenza. La mobilità del lavoro ne costiuisce un elemento importante, già oggetto di modellizzazioni che Stanziani ha discusso criticamente nel suo lavoro precedente Labor at the Fringes of Empire[2]. La pertinenza della mobilità per studiare le forme della coercizione viene sottolineata al di là di uno stretto economicismo, reinserendo le variabili del mercato all’interno di contesti socio-politici, rapporti di forza tra attori. Ad esempio, l’istituzione del servaggio viene collocata sullo sfondo del contestato progetto di migrazione e colonizzazione della steppa russa (pp. 31 e ss.). Le migrazioni stagionali del paysan-ouvrier e la persistenza della pluriattività accompagnano la formazione del salariato marittimo e manifatturiero in Francia e Inghilterra (pp. 129-130). O ancora, l’immigrazione a contratto verso le piantagioni si costruisce tanto su istanze di matrice militare contro la diserzione, quanto sull’esportazione di tipologie contrattuali fondate sul controllo padronale dell’intero tempo di lavoro (p. 211 e ss.). In molti casi, disciplina della concorrenza e disciplina del lavoro sono strettamente legate e la fuga si profila come arma di contrattazione a fronte di diritti limitati (intersecando strumenti di disciplina come il libretto operaio). Per altro verso, Stanziani dedica attenzione alle migrazioni interne e internazionali che si sviluppano nelle macro-aree prese in considerazione lunga la seconda metà dell’Ottocento, sottolineando che questa mobilità non è riconducibile unicamente all’espansione Occidentale, pur venendo in parte messa a valore da quest’ultima (pp. 251-255). E’ anche alla luce di queste migrazioni che viene introdotto il tema delle frontiere interne al nascente welfare lavorativo, i cui criteri di esclusione si organizzano tanto dentro il mondo del lavoro nazionale quanto in opposizione a quello immigrato.
Si giunge così al terzo angolo prospettico che desideriamo mettere in evidenza: le evoluzioni del rapporto contrattuale e in particolare l’emergenza del moderno “contratto di lavoro”. In esso, la subordinazione è considerata categoria giuridica intrinseca ai rapporti lavorativi, divenendo però anche via d’accesso ai nascenti diritti sociali. Questo assemblaggio tra controllo e tutela, che rimane comunque minoritario ancora a inizio Novecento, viene reinserito in una storia più ampia. Esso trova una sua importante anticipazione nel legame tra la coercizione del reclutamento marittimo e il regime pensionistico cui era connesso, per seguire poi la connessione tra nazionalizzazione delle protezioni e internazionalizzazione del mercato del lavoro (p.96). Per altro verso, l’evoluzione del contratto segue sentieri diversi nelle nuove colonie di sfruttamento. L’esempio del Congo francese mostra la persistenza di una molteplicità di regolamenti locali (il ruolo dell’imposta in particolare, p. 285 e ss.) associati a interpretazioni del lavoro come servizio. Compagnie concessionarie e amministratori locali si oppongono ai primi tentativi di esportazione delle protezioni sociali (1907 e 1911: qui il libretto tende a sovrapporsi al contratto di lavoro). Questo aspetto è interessante anche al di là dell’arco cronologico preso in considerazione da Stanziani, perchè anticipa le ambiguità dei successivi programmi di esportazione dello standard salariato e delle sue protezioni su impulso del Fronte Popolare e dell’International Labor Organization[3]. D’altro canto, è significativo che ancora negli anni Trenta le popolazioni locali stesse rifiutassero il contratto di lavoro, vedendovi in primo luogo la materializzazione di una coercizione inerente al processo di mercificazione del lavoro, anzichè una più vantaggiosa ripartizione di diritti e doveri tra le parti[4]. Da questo punto di vista, si potrebbero smorzare le molte critiche presenti nel testo alle prospettive marxiane. Stanziani sottolinea giustamente – in polemica con il marxismo economicista novecentesco – che la coercizione prolifera nel capitalismo, che la proletarizzazione è confrontata a una persistente pluriattività, che elementi giuridici ed istituzionali forgiano i rapporti di potere al di là di ogni economicismo, e che i diritti sociali e la loro (non)universalizzazione concorrono in maniera fondamentale a definire e gerarchizzare la libertà senza esserne pura sovrastruttura (pp. 305-309). Al tempo stesso, l’ironia tipicamente marxiana di una “libertà” nel senso di “espropriazione” troverebbe eco nelle pagine dedicate ai modi in cui si è impedito agli ex-schiavi di Reunion un accesso all’economia di sussistenza, o si è prodotta artificialmente la necessità di numerario tramite sistemi di tassazione in Africa Equatoriale Francese. Del resto, la storia globale del lavoro è stata fonte di ispirazione per rileggere pagine marxiane sull’accumulazione “cosiddetta originaria” sottolineandone il carattere processuale (irriducibile a un momento originario) e la diversità di esiti (irriducibile alle teleologie su cui una parte sostanziale del marxismo si era organizzata)[5]. Vi è insomma un passaggio logico, più che cronologico, nella critica marxiana al concetto di libertà. Al netto di semplificazioni astratte, i differenti modi di formazione di un mercato del lavoro possono risultare utili a interrogare il continuum temporale di dipendenza su cui si è storicamente misurata la libertà contrattuale (e pensata la distinzione tra servitù e salariato). Si tratta forse di due prospettive analitiche parallele sull’emergenza del lavoro-come-merce, i cui diversi accenti concorrono alternativamente a sottolineare gradazioni o cesure.
In conclusione, di Les Métamorphoses du Travail Contraint possiamo apprezzare il confronto serrato con i principali temi della storia globale del lavoro, la pluralità di prospettive rese operative per stabilire tanto connessioni quanto comparazioni, soppesare approcci “emici” ed “etici”, nonché l’impressionante apparato bibliografico cui il lettore può fare riferimento per la ricostruzione dei dibattiti. Ciascuno dei tre angoli prospettici che abbiamo individuato interagisce con diversi cantieri di ricerca, alla luce dei quali possiamo suggerire ulteriori piste di riflessione. In primo luogo, il tema delle categorizzazioni può essere ricostruito a partire dai processi di “istituzionalizzazione” di pratiche e usi del diritto, nonchè dal loro interagire definendo spazi giuridici transimperiali[6]. In questo senso è possibile riconsiderare in prospettiva globale il rapporto tra giurisprudenza, dottrina e ordine sociale – cioè la produzione di norme al di là di una rigida dicotomia top-down/bottom-up – presente in alcune ricerche sul contesto europeo che vengono citate nel libro[7]. Del resto, le considerazioni svolte da Stanziani sulla formalizzazione del lavoro coloniale come “service” e le rivendicazione (inascoltate) dei coolies nei tribunali possono venire lette anche in quest’ottica. In secondo luogo, il libro affronta il tema del welfare soffermandosi sulle sue frontiere nazionali e razziali/civilizzatrici, nonché sulle velocità multiple del suo sviluppo in base a settori e dimensione delle unità produttive. La prospettiva di genere risulta invece marginale e potrebbe essere maggiormente sottolineata[8]. Infine, l’attenzione alla mobilità del lavoro partecipa di un ampio rinnovo degli studi sulla diserzione del lavoro, al di là di una rigida corrispondenza tra il-libertà e im-mobilità. Le strategie di exit segnano un momento di agency che accompagna l’ambigua definizione del salariato moderno, solitamente associato alla libertà di auto-collocamento sul mercato del lavoro e all’assenza di penalità per rottura del contratto[9]. L’arco cronologico de Les Métamorphoses du Travail Contraint si ferma alle soglie delle grandi politiche di “migrazione scelta” di inizio Novecento, di cui pure anticipa i mutamenti nelle politiche di cittadinanza. Proseguendo nell’analisi si potrebbe esplicitare come il permesso di soggiorno – articolandosi con il permesso di lavoro – abbia posto le basi istituzionali per un rinnovo della coercizione rispetto al lavoro migrante[10]. Menzionare questo passaggio ha una rilevanza per l’oggetto della ricerca, nella misura in cui si tratta anche di storicizzare le gerarchie interne al mondo del lavoro mettendo in luce anche variabili formalmente ancillari al contratto. Gli effetti di lunga durata di questo assetto si esprimono infatti drammaticamente nel nostro presente attraverso lo stretto rapporto che intercorre tra i gradi di sfruttamento del lavoro e il più ampio governo della mobilità migrante (nei suoi diversi statuti di richiedente asilo, di clandestino o di permesso di soggiorno tempornaeo).
Martino Sacchi Landriani
[1] A.Stanziani, Les Entrelacements du Monde, CNRS Editions, Paris, 2017.
[2] A.Stanziani, Labor at the Fringes of Empire. Voice, Exit and the Law, Palgrave Macmillan, 2018.
[3] F.Ricciardi, “L’introvabile contratto di lavoro: appunti su ‘lavoro indigeno’ e inchieste coloniali (Africa occidentale francese, 1900-1940)” in N.Mignemi, C.Lorenzini, L.Mocarelli (eds.), Pluriattività rurale e lavoro agricolo in età contemporanea (sec. XIX-XX), Edizioni SISLav, Novembre 2020.
[4] Le Crom (eds.), Histoire du droit de travail dans les colonies françaises (1848-1960), Mission Droit&Justice, 2017, p. 96.
[5] Ad esempio D.Harvey, “The New Imperialism: Accumulation by Dispossession”, Socialist Register, 2004, pp. 63-87 e S.Mezzadra, « Attualità della preistoria. Per una rilettura del capitolo 24 del primo libro del Capitale », in La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale, Ombre Corte, Verona, 2008.
[6] Sul tema si può consultare ad esempio la collana Global Perspectives on Legal History editata dal Max Plack Institute. Il rapporto tra lavoro e diritto è attualmente al centro di una riflessione del gruppo di ricerca SISLav “lavoro libero e non-libero” e sarà oggetto di momenti di discussione nei prossimi mesi.
[7] Ad esempio la discussione svolta da Alain Cottereau sulla nozione di “veritable louage” a partire dagli archivi probivirali, e la reazione dottrinaria di fine secolo contro il contrattualismo civile classico. A.Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle) » in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2002/6, 57e année, pp. 1521 – 1557.
[8] Possiamo segnalare in proposito il progetto Reframing Welfare History in Modern Europe diretto da Laura Lee Downs, European University Institute.
[9] Oltre al già citato A.Stanziani, Labor on the Fringes of Empire, si veda M. Rediker, T. Chakraborty, and M. Van Rossum, eds., A Global History of Runaways: Workers, Mobility, and Capitalism, 1600–1850, California World History Library (Book 28), University of California Press, 2019. Il tema è inoltre al centro del Working Group “Im-mobilisation of the workforce” della COST Action WORCK www.worck.eu. In proposito è anche importante segnalare anche un testo che, scritto da un economista e poco citato dagli storici perchè privo di analisi diretta delle fonti, ha comunque avuto il merito di introdurre queste tematiche a inizio degli anni Novanta coniando il termine di “salariato imbrigliato”: Y.Moulier Boutang, De l’Esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, PUF, Paris, 1998.
[10] Tema centrale ad esempio negli studi sui programmi di migrazione organizzata novecentesca, come il sistema tedesco dei Gastarbeiter o quello del Bracero Program statunitense. Si veda C.Bernardi, Una storia di confine. Frontiere e lavoratori migranti tra Messico e Stati Uniti (1836-1964), Carocci, Roma, 2018. Per altro verso, l’articolazione tra politiche dell’asilo e sfruttamento del lavoro, nonché la costituzione di mercati del lavoro transnazionali attraverso il posted work, è un possibile snodo di dialogo con la sociologia del lavoro migrante contemporaneo. Si veda ad esempio il recente J.Arnholtz, N.Lillie (eds.), Posted Work in European Union. The Political Economy of Free Movement, Routledge, 2020.
Nel suo libro più recente Alessandro Stanziani riprende molti temi delle sue opere precedenti, tutte focalizzate sulla costrizione al lavoro, in diverse località del globo. Aggiunge però anche parti nuove (in particolare quelle sull’abolizionismo e sui domini europei in Africa), amplia o riduce risultati di ricerche passate, riformula alcune scelte. Sicché il libro si presenta come un’opera ricca di dettagli, dotata di un’aggiornata e abbondante bibliografia, e con una nuova struttura. Proverò innanzitutto a mettere in rilievo l’ossatura semantico-concettuale di cui l’autore si serve per legare le varie parti di un libro composito. Proverò poi a evidenziare alcune delle tesi specifiche che lo caratterizzano.
Non si dovrebbe tradurre il travail contraint di Stanziani con lavoro coatto, dal momento che egli stesso ha chiarito che l’espressione più appropriata è costrizione al lavoro: espressione che può contenere agevolmente sia il principale dei vincoli che legavano i salariati inglesi prima del 1875, sia i lavoratori europei che pagavano con una indenture il costo del viaggio verso il Nordamerica, sia infine gli engagées delle colonie francesi d’Africa. Tutti lavoratori che non erano formalmente schiavi, e che tuttavia sarebbe difficile definire liberi. Il lavoro di cui si tratta (condizioni socio-economiche, posizioni legali, modalità di accesso e uscita dal lavoro) è l’oggetto della ricerca; i lavoratori come soggetti non lo sono, se non in brevi passaggi. In questo senso il lavoro costretto è una categorizzazione, del tutto necessaria, dal mio punto di vista, per identificare il campo della ricerca: un astratto che, non diversamente da altre categorizzazioni che Stanziani contesta, non può sfuggire all’esigenza di verifica empirica della sua utilità euristica attraverso molteplici configurazioni storiche. Il libro presenta quindi uno dei problemi centrali di una storia globale del lavoro: come definirne l’oggetto, e come ricostruire i passaggi attraverso i quali le molte varietà di lavoratori nel mondo diventano soggetti non di tante storie locali, ma di un’unica storia connessa? Si tratta evidentemente di un compito di enorme difficoltà, sia per le competenze richieste (in primo luogo linguistiche) sia per la natura ed eterogeneità della documentazione necessaria. Contro la recente ondata di storie globali di ogni tipo e problema sono stati sollevati dubbi circa l’applicabilità del globale a ogni genere di storia. Stanziani stesso ha usato di recente, in Les entrelacements du monde, una definizione così inclusiva di storia globale che essa diventa quasi onnicomprensiva («De l’histoire universelle à la comparaison et à l’histoire connectée l’histoire globale inclut toute approche qui ne soit pas étroitement centrée sur una aire culturelle ou un pays», p. 11). Ma nel campo delle scelte concettuali l’ecumenismo non aiuta a individuare con precisione i problemi. In questo caso i problemi che rimangono non formulati mi sembrano vari. In primo luogo si tratta di sapere se i diversi spazi che dovrebbero comporre una storia globale siano connessi tra loro per affinità, per rapporto diretto, per interazione, o perché i loro mutamenti vanno nella stessa direzione. Nel libro l’esempio per me più convincente di una connessione a livello mondiale tra coercizione dei lavoratori e mutamenti delle condizioni di altri lavoratori è la sottolineatura, peraltro non nuova, di come l’emancipazione degli schiavi negli Stati uniti incidesse sul mercato mondiale del cotone inducendo a trovare nuove forme di coercizione dall’Egitto all’India (p. 249). Mi pare più discutibile, invece, la connessione per affinità a livello globale individuata da Stanziani nella comune ineguaglianza di status dei lavoratori e dei proprietari che caratterizza tutte le società analizzate. Questa affinità è condivisa da tante società nella storia e in tanti tempi diversi che diventa poco significativa per caratterizzare il carattere globale di uno specifico momento storico.
Il libro analizza diversi casi, in tempi diversi, di costrizione al lavoro, dall’Inghilterra alla Francia, dagli Stati uniti alla Russia fino all’Africa, a Mauritius e alla Réunion, ma è difficile capire in che senso le varietà siano connesse tra loro, se non attraverso i dibattiti in cui esse vengono discusse, e che spesso si rispondono a distanza. I dibattiti però sono condotti da frazioni diverse, e spesso in conflitto, di classi dirigenti, politiche, economiche, istituzionali. Di conseguenza vorremmo sapere, in secondo luogo, chi sono in quegli spazi i diversi agenti nella storia, e se ce ne sono anche altri, oltre ai nominati. Altrimenti è fin troppo facile cadere nell’ovvietà che la globalizzazione come processo è mossa dall’alto, da complessi di istituzioni, da chi controlla grandi strumenti economici. E quasi mai dai lavoratori, comunque definiti. La rete è del ragno, non di chi ci finisce impigliato, anche se trova in essa il modo di sopravvivere. Altrove Stanziani è stato attento a non attribuire alla globalità quella caratteristica di percorso predefinito e inevitabile della storia che giustamente è stato rimproverato alle storie centrate sul progresso, e in particolare a quelle centrate sul passaggio dal lavoro coatto al lavoro libero (cfr. Entrelacements, cit., p. 17). Ma forse sarebbe necessaria anche la distinzione tra globale come termine descrittivo e globalizzazione come categoria di analisi dei mutamenti in corso fatta da Geoff Eley. E viene in mente anche l’ammonimento di Frederick Cooper contro i rischi di attribuire importanza esplicativa ad astrazioni che non consentono la specificazione degli agenti (Cooper, Colonialism in question, p. 17). In effetti la distinzione tra globalizzazione, come processo, che è ciò che interessa lo storico, e globalità - come la vera o presunta, totale o parziale, condizione attuale del mondo - è troppo poco usata. Un rapido controllo su Google porta a ottenere 52.800 occorrenze per globalization contro 1.800.000 per globality, mentre l’aggettivo global che si può ormai applicare a ogni cosa, a cominciare da “global radiatori e caloriferi”, raggiunge l’inarrivabile picco di quasi 4 miliardi. Ma “global history” arriva a un ragguardevole 5.290.000 (non solo libri e articoli, ma anche corsi universitari e simili).
Quali che siano le scelte metodologiche di Stanziani nei confronti della storia globale, e le sue polemiche verso categorizzazioni, come quella di lavoro libero e lavoro non libero, da lui considerate astrazioni applicate impropriamente alla varietà delle situazioni storiche, in sostituzione delle necessarie contestualizzazioni specifiche, un tratto fondamentale di questo suo ultimo libro è il parziale spostamento dello sguardo dal mondo atlantico a quello indo-pacifico. Stanziani ha sempre mantenuto questa scelta nelle sue ricerche. Essa implica non solo l’indagine di un’area che non è stata altrettanto centrale di quella europea e americana nella ricostruzione dei mondi del lavoro, essa implica anche la penetrazione dello storico in un’area che, a differenza di quella euroamericana, non è costituita da società nettamente divise tra liberi e schiavi, ma da vaste aree grigie di lavoro costretto. Questa scelta è anche connessa a un equilibrio dei temi di ricerca nettamente spostato verso le situazioni successive alle emancipazioni dalla schiavitù, quelle caratterizzate dalla presenza di coolies, engagées, e simili. Invece della dicotomia liberi/schiavi, Stanziani ha scelto da molti anni travail contraint (e bondage in inglese) come il termine adatto a predefinire i tipi di lavoro al centro delle sue ricerche. Non mi sembra sempre chiaro nel libro se il termine copra solo gli specifici casi di costrizione al lavoro post-emancipazione, o tutti i casi di lavoro definibile come non libero, ed eventualmente secondo quali criteri.
Le tesi principali del libro, opportunamente sintetizzate da Stanziani nelle sue conclusioni, sono in primo luogo che il capitalismo non richiede affatto la relazione di lavoro che consiste nel lavoro salariato di persone libere, ossia che, fuori del rapporto di lavoro, sono libere come ogni altro nella società: una frase di Frances Hutchison nel Regno unito, a metà del Settecento. Qui Stanziani usa l’espressione “travail libre”. Ma chi è libero nelle varie società di cui si parla? In quali luoghi e tempi quella frase ha senso? Il capitalismo in effetti può funzionare benissimo anche con una forza lavoro costretta nelle più varie sfere della vita. Le ricostruzioni storiche più recenti del rapporto tra capitalismo e coercizione dei lavoratori hanno ampiamente insistito su questo punto (cfr. Sven Beckert e Seth Rockman); e anche i fenomeni che sono sotto i nostri occhi sembrano confermare che sistemi economici capitalistici sono attualmente alla ricerca di forme, vecchie e nuove, di costrizione. Questa tesi, largamente condivisibile dal mio punto di vista, apre tuttavia due problemi. Il primo è come categorizziamo il capitalismo una volta che il rapporto lavoro salariato/capitale non è più centrale nella definizione (salvo che non si ritenga sufficiente la notazione che il capitalismo è appunto quel sistema economico che può funzionare benissimo sia con lavoro salariato libero sia con lavoro coatto, e magari ha bisogno proprio della coesistenza di entrambi). Il secondo problema è se possiamo considerare irrilevante la dimensione relativa dei settori di lavoro salariato e di lavoro costretto, ovvero se, in un’economia capitalistica, debba esistere tra i due qualche forma di proporzione funzionale. Nel libro di Stanziani non viene articolata nessuna risposta né al primo né al secondo problema. Nell’analizzare il caso dei domini francesi in Africa l’autore insiste sulla frustrazione delle imprese in quelle aree a causa della scarsità di profitti prima del 1914; ma ridurre il capitalismo a un caso indefinito di ricerca del profitto sarebbe un grande passo indietro storiografico.
Ho detto, impropriamente, del lavoro salariato come la relazione di lavoro in cui i lavoratori, fuori del lavoro, godono di tutti diritti di cittadinanza. Ho dovuto farlo perché Stanziani connette la dissociazione tra capitalismo e lavoro salariato con la dissociazione tra capitalismo e democrazia, in primo luogo in Russia, in forma estrema in Africa, negli Stati uniti dopo l’emancipazione (pp. 305-306). Qui l’autore introduce la questione dei diritti politici come misura di libertà e costrizione. Ora, a parte l’anacronismo - a dir poco - di considerare Adam Smith come un sostenitore di questa associazione, quando si rifiuti la contrapposizione tra lavoro libero e lavoro costretto, lo storico che oggi voglia ricostruire il dibattito sullo status dei lavoratori, ad esempio in Gran Bretagna e in Francia almeno dal XVIII e fino alla metà o più del XIX secolo, ha prima di tutto il problema di spiegare perché lavoratori che a noi appaiono ovviamente non liberi dal punto di vista civile (cfr. i capp. 3 e 4 del libro), a prescindere dai diritti politici – la cui mancanza, del resto, non riguardava solo loro - apparissero invece ai contemporanei come dei liberi. O, meglio, apparissero come liberi ad alcuni contemporanei, mentre altri li consideravano non liberi, o almeno come tali che non avrebbero dovuto essere liberi, come minimo non liberi quanto i veri cittadini. Per affrontare questo problema non si può evitare di riconoscere che, in entrambi i paesi, c’era conflitto tra concezioni diverse della libertà, della libertà in generale, e della libertà dei lavoratori in particolare: un conflitto in cui la posizione dei salariati nella società era un nodo cruciale, ma non unico. Sicché ogni ricostruzione che assuma come troppo simili le posizioni contrapposte nei dibattiti rischia di oscurare il punto del contendere. Il quale era il grado di autonomia nell’esercizio di funzioni pubbliche che si poteva riconoscere al lavoratore salariato - e quindi dipendente da un padrone per la sua possibilità di lavorare e disporre della propria sussistenza – quando la legge richiedeva che il voto fosse pubblico. Mi pare che l’autore incorra in questo rischio quando in questo stesso ragionamento parla di “uguaglianza di diritti nel mercato del lavoro”, e non contestualizza in luoghi, tempi, e paradigmi il sorgere di una questione democratica
La seconda tesi, che è decisiva per la struttura di questo libro, è che fino alla seconda rivoluzione industriale, comunque la si collochi cronologicamente e funzionalmente (e Stanziani non è chiarissimo su questo punto) il problema cruciale per qualsiasi impresa era la disponibilità di mano d’opera, il lavoro e non già il capitale essendo il motore dello sviluppo (pp. 309 e 313) dalle colonie americane ai possedimenti inglesi in Oriente fino ai domini francesi in Africa (un tema già presente con molta forza in Bondage). Di qui il filo conduttore di molte ricerche di Stanziani, ossia che le abolizioni di schiavitù negli Stati uniti e di servaggio in Russia (termine che l’autore non vorrebbe veder usato) non siano state un reale fattore di cambiamento nella storia dell’umanità, ma solo un inizio in una storia di metamorfosi della costrizione al lavoro - una storia messa in moto dalla volontà di vari gruppi di comando di procurarsi lavoro ad ogni costo, e dalla loro convinzione di poterlo ottenere solo usando coercizione. In effetti, nella storia ricostruita da Stanziani proprio la concorrenza tra imprese, tra poteri coloniali, in ultima istanza tra imperi, al fine di ottenere lavoratori offre a questi ultimi alcuni spazi di resistenza e di negoziazione, accanto al ricorso alla giustizia, più difficile, e alla fuga da un padrone a un altro. Proprio a proposito della connessione tra concorrenza dei padroni del gioco e risposte degli asserviti, l’autore nella conclusione tratta in modo più sistematico il problema degli spazi di iniziativa di cui potevano servirsi i lavoratori costretti. Proprio qui emerge nel modo più chiaro che gli attori di questa storia sono fondamentalmente gli apparati statali, nelle loro varie articolazioni, le classi dominanti, siano proprietari terrieri sia il grande commercio, le élites locali. In una frase, è una storia dall’alto; che è una storia molto utile per capire il passato, e contro la quale non ci possono essere obiezioni, ma che non è una storia dei lavoratori come agenti, solo delle condizioni in cui essi si trovano ad agire.
Infine, un ultimo punto è necessario alla costruzione della storia messa in opera in questo libro. Se gli sforzi e le spese sostenute per erigere e sostenere i sistemi coloniali erano così gravosi di fronte agli scarsi profitti, perché le potenze europee hanno persistito così a lungo nelle imprese imperiali, compresa la spietatezza nel loro trattamento dei lavoratori? Stanziani scarta quelle che considera spiegazioni “convenzionali” dei fenomeni che spingevano al colonialismo europeo, ossia le spiegazioni economiche: ma direi piuttosto alcune specifiche spiegazioni economiche, a partire da quella di Hobson. Essa insisteva sul fatto che il grande sovrappiù di capitale accumulato nei paesi europei cercava in altre parti del globo, non ancora penetrate, quegli impieghi profittevoli che non riusciva più a trovare in patria. In realtà Stanziani, oltre a notare una molteplicità di fattori, politici, geopolitici, culturali, offre a sua volta una spiegazione economica: i primi passi dello stato sociale in fieri in Europa aumentano il costo del lavoro nei territori metropolitani, e quindi spingono le classi padronali a cercare compensazione per le concessioni che fanno fatto in patria nel lavoro a basso costo che possono trovare altrove. Purtroppo, nulla è detto dell’aumento del costo del lavoro prima della guerra mondiale, come nulla si dice dei problemi della disoccupazione in Europa, né delle imprese che compiono quelle mosse, salvo che le loro aspettative sono frustrate.
Quest’ultima tesi è necessaria nell’equilibrio dell’opera per mantenere la connessione tra la storia dei lavoratori in Europa e la storia delle varie forme di lavoro costretto in giro per il mondo. Dire, come Stanziani (pp. 280, e anche 268, 302), che queste varie forme, le connesse violenze e sanguinose repressioni avvengono “nel contesto” dei miglioramenti ottenuti dai lavoratori metropolitani a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo non è sufficiente. Al momento la vecchia teoria che connetteva l’eccesso di sovrappiù alle ineguaglianze delle società metropolitane sembra ancora offrire una migliore spiegazione.
È rilevante notare che il tema della scarsità di lavoratori disponibili, che è sempre stato uno degli argomenti principali in difesa della schiavitù nelle Americhe, ha largamente cambiato di significato da quando, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, la storia della schiavitù negli Stati uniti non è stata analizzata più come un caso di lunga stagnazione e poi crisi dell’economia schiavistica, bensì come parte di un contesto caratterizzato da grande profittabilità, produttività, e anche sviluppo. Il quadro della costrizione al lavoro dopo le emancipazioni e prima della guerra mondiale tracciato da Stanziani assomiglia di più, per vari aspetti, a quello delle vecchie storie dell’economia schiavistica. Questa sottolineatura dei fallimenti economici dovrebbe segnare un rapporto più complesso e problematico di quello evidenziato nel libro tra i sistemi schiavistici americani e i nuovi lavori costretti.
Maria Luisa Pesante
Riferimenti
Sven Beckert and Seth Rockman (eds.), Slavery’s capitalism: A new history of American economic development, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2016
Frederick Cooper, Colonialism in question: Theory, knowledge, history, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2005
Geoff Eley, Historicizing the Global, politicizing capital: Giving the present a name, «History Workshop Journal», #65, Spring 2007, pp. 154-188.