Discussioni 14
Discussioni #14
Fabrizio Loreto, Corine Maitte e Nicoletta Rolla discutono:
Franco Ramella (trad. I. Giordano, M. Gribaudi, C. Maitte, M. Martinat, et N. Rolla),
Terre et tissages, Systèmes de parenté et manufacture dans la région de Biella au XIXᵉ siècle.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025.
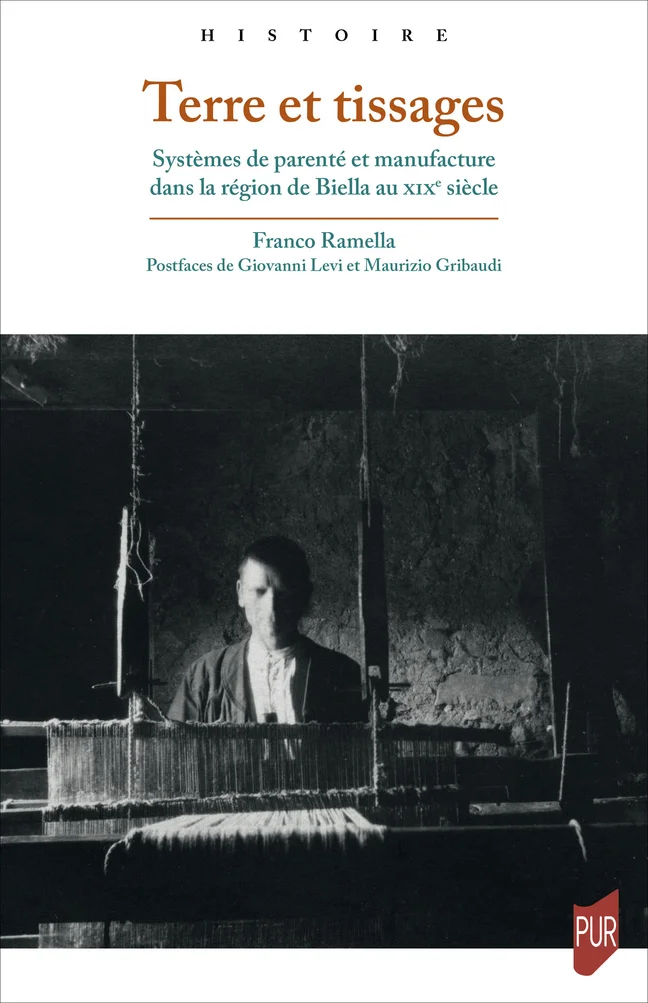
La pubblicazione dell’edizione francese del libro di Franco Ramella Terra e telai (Terre et tissages. Systèmes de parenté et manufacture dans la région de Biella au XIXᵉ siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2025, € 25) rappresenta un’occasione utile per tornare a riflettere su uno dei volumi più preziosi sulla storia dell’Italia contemporanea: un saggio, divenuto ormai un classico della storiografia1, scritto da uno studioso tanto schivo quanto autorevole, al quale la Società Italiana di Storia del Lavoro ha dedicato un’apposita sezione del sito internet dopo la sua scomparsa nel 20202.
Il libro uscì per l’editore Einaudi nel 1984, nella celebre collana Microstorie, con l’introduzione di Giovanni Levi; divenuto introvabile, è stato ristampato in Italia da Donzelli nel 2022, con una prefazione di Maurizio Gribaudi. Entrambi i contributi – di Levi e Gribaudi – sono presenti anche nell’edizione francese, collocati alla fine del volume affinché Terre et tissages possa costituire – come scrivono nell’introduzione le curatrici Corine Maitte, Monica Martinat e Nicoletta Rolla – anche una sorta di «document historique qui permet de saisir des temporalités différentes dans la réception d’un ouvrage important» (p. 9). L’introduzione sottolinea due elementi essenziali dell’opera di Ramella: l’approccio microstorico, che punta alla «généralisation des questions» e alla «localisation des réponses» (p. 16); e una lettura interpretativa ancora attuale, capace di cogliere nodi storici rilevanti.
«Terra e telai è un testo che si presta ad una lettura multistrato». Così scrive Gribaudi nella prefazione del 2022 (p. XI), sintetizzando in modo efficace tutta la ricchezza del libro, che racconta – come un vero e proprio romanzo – le vicende del territorio biellese nella transizione dall’Antico regime alla Rivoluzione industriale, ponendo al centro i mutamenti e le continuità del lavoro nella vita quotidiana del “lungo Ottocento”, e offrendo anche scorci affascinanti sul paesaggio, tra boschi e campi, torrenti e vallate.
Il volume ricostruisce, innanzitutto, l’evoluzione demografica della popolazione locale, analizzando alcuni fenomeni quali lo spostamento in avanti dell’età al matrimonio delle donne e il ritardo nel concepimento dei figli, il largo ricorso all’endogamia e l’ampia diffusione del “padrinaggio”, l’aumento dei figli cosiddetti “esposti” ma anche la stabilizzazione del tasso di mortalità infantile. Si tratta, in generale, di fatti e comportamenti che vengono spiegati alla luce del cambiamento epocale in corso, che Ramella definisce come l’opposizione tra il “ciclo agricolo” e il “ciclo industriale”: frenare la crescita della popolazione, attingere (sempre meno) alla terra e (sempre più) ai salari, cementare le alleanze familiari e sociali sono allora tutte strategie con cui un’intera comunità cerca di “governare” una lunga e complessa transizione verso un mondo nuovo e una nuova epoca.
Al centro della narrazione vi sono famiglie estese, coresidenti, guidate da dinamiche patriarcali, nelle quali tuttavia le donne mantengono ruoli fondamentali. L’obiettivo è comune: accrescere “la densità delle reti sociali” – come mostrano le pagine mirabili dedicate al podere della “passera” – rafforzando le relazioni di vicinato, alimentando la cooperazione nei campi e la solidarietà nei primi opifici, sostenendosi sul piano creditizio. Alla storia sociale si affianca poi quella economica: Ramella segue la nascita delle prime imprese industriali nel settore produttivo dominante, il tessile laniero; e segue l’evoluzione successiva, con l’avvento della meccanizzazione nella filatura, la parabola della tessitura domestica e la piena affermazione del sistema di fabbrica, dove presto si assisterà all’avvento del telaio meccanico. Infine, non può mancare la dimensione politica, legata alle inevitabili dinamiche di potere tra i soggetti sociali, specie quando i fabbricanti di pannilana da un lato e i tessitori a mano dall’altro inizieranno a organizzarsi per far valere i rispettivi interessi, coinvolgendo le istituzioni.
In sintesi, Terra e telai resta un esempio mirabile di “storia come storia del lavoro”, à la Dal Pane3: una storia generale in cui la totalità degli aspetti del lavoro (economici, sociali, politici, culturali) permette di illuminare i rapporti di produzione, le gerarchie sociali, le relazioni di potere e le egemonie culturali in un determinato contesto storico. I protagonisti del libro, infatti, sono i tessitori a mano, in grado di guidare un’intera comunità grazie al sapiente impiego di tre strumenti: la terra, che però perde rilevanza con il passare degli anni, a causa delle incertezze dei mercati; il mestiere, che si trasmette di generazione in generazione con grande cura, in quanto risorsa che permette di controllare il mercato del lavoro; e le reti sociali, che favoriscono una difesa più efficace degli interessi economici4.
La storia narrata da Terra e telai si snoda tra il 1854 e il 1889, anche se considera una fase protoindustriale più ampia, il cui avvio risale al passaggio tra il XVIII e il XIX secolo. Il libro analizza un vero e proprio ciclo conflittuale, in quattro tappe. La prima riguarda i tumulti alimentari del 1854, un esempio di ribellione tipica dell’età moderna, la cui “moralità” scaturisce dal consistente aumento del prezzo dei cereali, ritenuto intollerabile dalle classi popolari. Il conflitto, tuttavia, presenta già una significativa novità: il bersaglio della protesta annovera, per la prima volta, anche i “fabbricanti di pannilana”, cioè quegli imprenditori – primi fra tutti i Sella – che stanno portando la Rivoluzione industriale a Biella e nelle sue valli orientali (Strona e Sessera, con epicentro a Mosso).
Appena dieci anni dopo, nel 1864, il conflitto sociale riappare, ancora più esteso e radicale, questa volta sotto forma di un vero e proprio sciopero. A causa del rafforzamento del fronte imprenditoriale, infatti, i tessitori hanno dovuto abbandonare repentinamente il loro lavoro (autonomo) a domicilio, calcato sui ritmi della terra e sulla pluriattività, per diventare operai (dipendenti), subordinati al nuovo “regime di fabbrica”, segnato dal ritmo delle macchine. I telai, tuttavia, sono ancora a mano; e gli opifici, dunque, continuano ad avere bisogno di quei tessitori. Questi, forti del loro potere, resistono in modo tenace alla perdita di libertà, fissata dalle norme soffocanti dei Regolamenti interni: orari e turni prestabiliti, divieti disciplinari nei reparti e sorveglianza asfissiante, cui corrispondono multe salate che colpiscono le paghe. La forma inizialmente più visibile di resistenza è l’assenteismo, specie nel primo giorno della settimana (il famigerato “lunediare”); ma le fonti registrano anche lettere minatorie anonime, dimissioni e anche la pratica del “sonno coatto”, cioè la siesta pomeridiana forzata che i più combattivi, specie tra i giovani, impongono agli altri operai. È in tale contesto che si diffondono le pratiche di sociabilità, anche “esuberanti”, con epicentro nelle osterie, tra vie crucis di bevute e serenate sbeffeggianti; e maturano le prime forme di associazionismo – circoli vinicoli, cooperative e società operaie – che prendono il posto delle vecchie confraternite di natura devozionale. Ed è in tale contesto, soprattutto, che nasce il sindacato, cioè l’organizzazione di resistenza collettiva, inizialmente clandestina, evoluzione ribelle del mutualismo, la quale promuoverà lo sciopero. La prima importante mobilitazione operaia risulta vittoriosa, chiudendosi con la firma del Lodo Mancini, primo esempio di accordo collettivo che sostituisce il vecchio “regolamento dei sette dolori”.
Tredici anni dopo, nel 1877, lo schema si ripete, simile ma con qualche variante: gli imprenditori, imitando i tessitori, si riuniscono in un cartello segreto, facendo accorrere negli opifici i “beduini”, nel tentativo, fallito, di usare l’arma del crumiraggio; e mentre la tensione sociale cresce, spingendo le autorità a esercitare una forte stretta repressiva, a Roma si pensa a istituire un’apposita commissione d’inchiesta in Parlamento per studiare il fenomeno inedito degli scioperi ed escogitare le opportune contromisure. La novità principale, tuttavia, è un’altra: di fronte alla nuova affermazione operaia, il fronte datoriale decide di spostare la contesa su un altro terreno, quello dell’organizzazione del lavoro, introducendo in breve tempo e in modo massiccio i telai meccanici nelle fabbriche. Il risultato è immediato: la gran parte dei tessitori a mano resta disoccupata ed è costretta a migrare per poter sopravvivere. Entra così nelle industrie una manodopera prevalentemente femminile, composta soprattutto da donne legate da vincoli familiari e comunitari ai vecchi tessitori, le quali, però, iniziano a mostrare da subito segnali di insofferenza, che crescono nel tempo.
La storia, infine, si chiude nel 1889, con il nuovo, grande sciopero delle tessitrici meccaniche biellesi. L’evento, come nota Ramella nelle battute finali del volume, mostra in modo chiaro la trasmissione – avvenuta nel tempo, di generazione in generazione, per via parentale e sociale – di un vero e proprio modello culturale, segnato dalla «eccezionale capacità di resistenza, di adattamento e di mutamento mostrata dalle strutture sociali, sempre diverse e sempre riprodotte».
A ben vedere, dunque, la parola-chiave del libro sembra essere proprio “resistenza”. «Le certezze che ci sono state impartite dalle dottrine, dai partiti o dai partiti-Stato e dai loro capi sono andate in pezzi e […] invece continua a vivere come testimonianza di verità la resistenza collettiva e individuale di chi lavora. Anche quando sogna l’impossibile essa chiede maggiore giustizia e maggiore libertà, chiede di poter disporre meglio del proprio futuro e anche (perché no?) di stare un pochino meglio»5. Così scriverà nella sua autobiografia Vittorio Foa, antifascista, partigiano, costituente, sindacalista e storico del lavoro, appena sette anni dopo l’uscita di Terra e telai. Non sappiamo se Foa abbia letto il libro di Ramella. Di certo, i due si conoscevano: avevano vissuto negli anni sessanta la comune militanza nella sinistra socialista, politica e sindacale; lo stesso Foa – che nel 1973 aveva aperto con gli scioperi biellesi il suo saggio sui sindacati per la einaudiana Storia d’Italia6 –aveva poi scritto, insieme a Pietro Marcenaro, un volume per la collana Microstorie, uscito nel 1982 con il titolo Riprendere tempo. Mi piace pensare, in conclusione di queste brevi note, che la riflessione di Foa possa essere scaturita, seguendo traiettorie nascoste e imprevedibili, anche da un dialogo su quelle «piccole storie di tessitori alle radici del movimento operaio»7 (Nani 2007) raccontate in modo magistrale qualche tempo prima da Franco Ramella.
Fabrizio Loreto
Università di Torino
***
Può sembrare strano tradurre in francese, quarant'anni dopo la sua prima pubblicazione, un testo che studia la storia movimentata di una piccola valle piemontese nel XIX secolo. Eppure, quest'opera ci parla oggi in modo duplice. Da un lato, entra in dialogo con la storia del mondo del lavoro, il cui attuale rinnovamento deve molto alla prospettiva aperta anche da Ramella. Dall'altro, con le introduzioni che hanno accompagnato le due edizioni italiane – quella di Giovanni Levi, in occasione della prima pubblicazione del libro nella collana Microstoria dell'editore torinese Einaudi nel 1984, e quella di Maurizio Gribaudi in occasione della riedizione del testo nel 2022 presso l'editore romano Donzelli – questo libro costituisce un documento storico che permette di cogliere le diverse temporalità del dialogo tra due storiografie, quella italiana e quella francese.
Per contestualizzare il libro, è necessario ricordare a grandi linee i principali orientamenti della storia del lavoro in Italia e in Francia prima della sua pubblicazione nel 1984.La storia del lavoro e dei lavoratori che Ramella implicitamente mette in discussione è da un lato quella del «movimento operaio» e dall’altro quella dei processi di industrializzazione, due ambiti che sono intimamente legati.
Secondo l’efficace ricostruzione di Stefano Musso8, nella seconda metà del Novecento la storia del lavoro in Italia ha conosciuto tre grandi stagioni. Lo stesso può essere ravvisato in Francia contemporaneamente, seppur con alcune importanti differenze. Una prima fase “etico-politica”, prevalente negli anni Sessanta e influenzata dall’idealismo storicista, ha prodotto studi incentrati sul ruolo delle istituzioni e dell’imprenditoria, sulle strategie dei dirigenti sindacali e politici. Negli anni Settanta, in un contesto di forte conflittualità sociale e di mobilitazione della classe operaia, si afferma una storia del lavoro chiaramente e dichiaratamente militante, che produce lavori interessati soprattutto ai gruppi sociali e alle lotte dei lavoratori. Secondo Stefano Merli, uno dei più autorevoli rappresentanti di questo ciclo, sulla storiografia del movimento operaio «pesano responsabilità che sono ben più grosse di quelle che solitamente competono a una branca specializzata della cultura […] per la sua capacità […] di essere cioè un’arma critica di questa lotta»9. A questa stagione non è sicuramente estranea l’impressione destata dalla circolazione in Italia del libro fondativo di E.P. Thompson, The making of English working class tradotto in italiano nel 1969 da Bruno Maffi con il titolo Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra10, mentre in Francia l'opera è stata tradotta solo vent'anni dopo e la sua influenza sulla storiografia francese è stata in quella congiuntura senza dubbio minore. Come nel libro di Thompson, il tema dominante nella storia del lavoro in Italia era allora la formazione della classe operaia, che viene osservata all’interno della fabbrica come luogo di lavoro dove si forma la coscienza di classe, conseguenza diretta di rapporti di forza e di sfruttamento dei lavoratori. Proliferano allora gli studi sulla composizione della classe operaia per sesso ed età, sui livelli salariali, sull’organizzazione del lavoro, sulla qualificazione dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro per rintracciare i fattori di unità alla base della coscienza di classe e della sua capacità di mobilitazione.
Questa ricca stagione di studi è stata seguita da un momento di crisi della storia del lavoro, intesa come storia del movimento operaio, parallela alla fine della centralità - politica e sociale - della classe operaia. Da una parte questa crisi è da ricondurre alla delusione provocata dalla sconfitta delle lotte operaie e di una su tutte, quella dei 35 giorni alla Fiat di Torino (11 settembre-14 ottobre 1980), che si concludeva, dopo la “marcia dei Quarantamila” (14 ottobre 1980), con la chiusura della vertenza tra sindacati e azienda con un accordo favorevole alla Fiat. Dall’altra, il processo di decentralizzazione e di ristrutturazione aziendale degli anni Ottanta, seguite negli anni Novanta da una divisione internazionale del lavoro sempre più accentuata dalla globalizzazione, hanno portato ad una terziarizzazione della manodopera, con una conseguente perdita di centralità della classe operaia.
La fine della grande stagione di storia del movimento operaio non si traduce però in una fine della storia del lavoro in Italia, che continua a produrre – sebbene in numero minore – lavori di notevole interesse. Sono anche gli anni in cui in Italia, come in Francia, si raccolgono gli stimoli portati da un nuovo approccio alla storia dell’industrializzazione e in particolare da una nuova parola chiave, protoindustria, comparsa per la prima volta in un articolo dello storico olandese Franklin Mendels, Proto-industrialization: The First Phase of the Industrialization Process, pubblicato su “The Journal of Economic History”11. Il modello protoindustriale proposto da Mendels arriva in Italia attraverso la ricezione del volume di Peter Kriedte, Hans Medick e Jürgen Schlumbohm nella sua traduzione L’industrializzazione prima dell’industrializzazione12. Sebbene questo libro non sia mai stato tradotto in Francia, i dibattiti sul questo tema sono stati però forse più vivaci che in Italia, soprattutto sulle pagine di riviste come la Revue du Nord e le Annales, che gli consacrarono numeri monografici, e approfondimenti specifici in tesi di dottorato dirette in particolare da Pierre Deyon13 (G. Gayot, o Didier Terrier per fare solo due esempi).
È in questo contesto intellettuale e storiografico che matura l'opera di Franco Ramella, che riprende e approfondisce la tesi di laurea della sua compagna Luciana Benigno14, dedicata allo sviluppo della produzione tessile nella regione di Biella nel XIX secolo. La sua esperienza personale e di ricerca si iscrive in questo clima di delusione per gli esiti di una stagione politica che si chiudeva e a cui aveva partecipato in prima persona, e di apertura verso nuovi approcci di ricerca che in quegli anni avevano trovato nella microstoria la sua punta più avanzata. Inutile ricordare qui che l'opera di Ramella è pubblicata nella collana Microstorie della casa editrice Einaudi. Si può senza dubbio affermare che all'origine del progetto microstorico nell'Italia degli anni '70-'80 vi era la volontà di rivisitare i paradigmi scientifici e politici che fino ad allora avevano guidato la lettura del passato. Si trattava di un modo particolare di concepire il rapporto tra ricerca storica e impegno politico: si voleva sia rinnovare l'interrogativo storico attraverso l'impegno, sia alimentarlo grazie al lavoro scientifico. L'opera di Ramella è maturata in questo contesto, mettendo in discussione i paradigmi tradizionali incapaci di rendere conto di una realtà molto più complessa di quanto i modelli consolidati lasciassero intravedere. È in parte contro le semplificazioni della storia operaia trionfante degli anni '70 che si colloca, come pure in dialogo tacito e critico rispetto al modello protoindustriale (mai citato esplicitamente).
In Francia, la storiografia del lavoro segue itinerari in parte simili a quelli italiani. Come in Italia, fino alla fine degli anni '70, domina una storia militante del “movimento operaio”, di cui si ripercorrevano le lotte, la presa di coscienza in una lunga marcia che lo opponeva, blocco contro blocco, al “padronato” attraverso una serie di episodi salienti, glorificati per le esigenze di una memoria proletaria, se possibile rivoluzionaria15. Questi anni hanno dato luogo a diverse iniziative significative. Già nel 1955 nasce il progetto del Dizionario biografico del movimento operaio francese, il cui primo volume (A-Cz) appare nel 1964 sotto l'egida di Jean Maitron16. Il grande libro di Michelle Perrot Les ouvriers en grève, 1871-1890 uscì nel 1973 e divenne rapidamente un classico17. Si trattava innanzitutto di capire, attraverso uno studio quantitativo, se la Comune del 1871 avesse interrotto il movimento di rivendicazione e di cogliere la «spontaneità» dello sciopero nel suo movimento «giovanile». Quel mondo era dominato dall'operaio proletarizzato, figura emblematica della «rivoluzione industriale», che lasciava largamente da parte, purché non protestassero, tutte le altre declinazioni dei lavoratori come figure arcaiche o marginali. Questa storia andava di pari passo con la storia teleologica della “rivoluzione industriale”, di cui l'Inghilterra mostrava la via trionfale, mentre sul continente se ne cercavano avatar più o meno riusciti.
Dopo la vittoria della sinistra alle elezioni presidenziali del 1981, che sembra invece ridare speranza, la svolta dell'austerità, nel 1983, apre anche in Francia una serie di delusioni che colpiscono duramente il movimento operaio, con conseguenze anche sugli studi di storia del lavoro.
Se queste due storiografie camminano parallelamente, dialogano relativamente poco. Ne è testimone l’assenza di traduzione reciproca dei libri qui citati. All’interno di essi, l’assenza di riferimenti agli studi realizzati dall’altra parte delle Alpi dimostra che non si tratta solo di scelte editoriali. Tutt’altro si nota al contrario nella “nuova” storia del lavoro nata in Italia come in Francia, e in molti altri paesi, dopo il 2000. È stata una nuova crisi – economica e sociale – a imporre nuovamente l’esigenza di interessarsi ai mondi del lavoro in una prospettiva storica. La crisi finanziaria del 2007-2008 - alla cui origine vi era anche la svalorizzazione del lavoro e la perdita di potere d’acquisto dei lavoratori – ha avuto pesantissime ricadute sul mondo del lavoro. Nel caso specifico dell’Italia, la crisi internazionale si innestava sulle trasformazioni del mercato del lavoro che una serie di riforme avevano accompagnato, puntando, per accrescere l’occupazione, sulla flessibilità e su nuove tipologie contrattuali che hanno di fatto precarizzato il lavoro. In questo contesto una nuova generazione di studiosi, colpiti direttamente nei loro percorsi personali e professionali dalle nuove condizioni del mercato del lavoro, insieme a studiosi affermati, hanno rimesso il lavoro al centro dell’interesse storiografico. In questo clima di rinnovato interesse per la storia del lavoro, sono nate società scientifiche come la Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLav) e l’Association française d’histoire des mondes du travail (AFHMT), una rete internazionale di studiosi, l’European Labour History Network (ELHN), impegnate nella promozione e diffusione di studi di storia del lavoro. Alla moltiplicazione di iniziative su questo tema l’AFHMT e la SISLav hanno largamente contribuito, collaborando strettamente fin dalla loro fondazione. La traduzione di Terra e telai è anche il frutto di questa collaborazione destinata a colmare una sorprendente lacuna.
La ricezione della microstoria in Francia negli anni ‘90 è infatti legata a itinerari personali e professionali che hanno nutrito uno scambio scientifico tra i più ricchi e fecondi, di cui alcuni risultati sono stati pubblicati da case editrici francesi. Fra gli esempi più salienti sono Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg, tradotto abbastanza rapidamente dopo la sua pubblicazione italiana (Einaudi, 1976; Flammarion, 1980); Mondo operaio e mito operaio di Maurizio Gribaudi, apparso contemporaneamente in Italia e in Francia (Einaudi, 1987; editions de l’EHESS, 1987); L’eredità immateriale di Giovani Levi (Einaudi, 1985; Gallimard, 1989), con lunga introduzione di Jacques Revel sulla microstoria; o ancora La ville et les métiers di Simona Cerutti, apparso prima in Francia (1990) che in Italia (1992). Non è il caso di Terra e telai, che costituisce però un tassello importante di quella stagione storiografica, purtroppo rimasto inaccessibile alla maggior parte del pubblico francese. La sua traduzione colma quella che appare chiaramente come una mancanza tanto più deplorevole in quanto avrebbe potuto costituire un elemento di paragone e di dialogo con alcuni studi francesi (per esempio il libro di Didier Terrier, Les deux âges de la protoindustrie18),come pure un trampolino di lancio per rivitalizzare prospettive in fase di esaurimento: i lettori francesi potranno trarne non solo una lezione metodologica, ma anche spunti per comprendere uno spazio alpino, epicentro delle migrazioni italiane verso la Francia nell'epoca moderna e contemporanea.
L’approccio globale alla storia, così centrale nella riflessione storiografica contemporanea, sembra opporsi radicalmente alle pratiche microstoriche, diventate nel frattempo sinonimo di studi locali. Ma non è così. La dimensione mondiale non esclude necessariamente quella locale: Marcel Van der Linden oltre dieci anni fa promuoveva infatti una storia mondiale del lavoro attraverso la ricostruzione dei percorsi migratori dei lavoratori, invitando a pensare il mondo attraverso le connessioni e le relazioni sociali19. Allo stesso tempo, sono state fatte esperimenti di applicazione del metodo microstorico alla Global History, come quello promosso da Christian de Vito e Anne Gerritsen che nei loro studi tengono insieme la scala globale e quella locale20.
La traduzione di Terra e telai rappresenta anche un tentativo di recuperare quella dimensione politica e polemica, che ha accompagnato la nascita della microstoria e che si è attenuata in seguito. Questa componente non è stata necessariamente visibile nell'esportazione di questa pratica storiografica all'estero, dove è sopravvissuta piuttosto la sua dimensione epistemologica, rivisitata secondo paradigmi storiografici «nazionali»21. Ma essa rimane al centro della prima microstoria e può essere recuperata. Rifiutare qualsiasi semplificazione della realtà storica e il suo confinamento in modelli incapaci di rendere conto dell'azione degli uomini e delle donne protagonisti della storia è di per sé un approccio politico. Terra e telai, entrando nel cuore del processo di industrializzazione e di profonda trasformazione della società, osservandolo da una prospettiva ravvicinata, dando peso alla dimensione famigliare e comunitaria in cui si inseriscono le azioni degli individui, ci ricorda che il mondo come lo conosciamo oggi è solo una delle opzioni possibili.
Corine Maitte
Université Gustave Eiffel
Nicoletta Rolla
Università di Torino
Società Italiana di Storia del Lavoro
1Pacini Monica, Soldani Simonetta (a cura di), «I “percorsi rizomatici” di Franco Ramella», Passato e Presente, n. 119, 2023, pp. 15-51
2https://www.storialavoro.it/materiali/franco-ramella/
3Andrea Caracausi e Michele Nani discutono: Luigi Dal Pane, La storia come storia del lavoro. Discorsi di concezione e di metodo, Bologna, Pàtron 1968, www.storialavoro.it/discussioni-1/
4Tilly Louise A., «A proposito di Terra e telai di Franco Ramella», Movimento operaio e socialista, n. 3, 1985, pp. 487-492
5Foa Vittorio, Il Cavallo e la Torre. Riflessioni su una vita, Einaudi, Torino 1991, pp. 214-15.
6Id., «Sindacati e lotte sociali», in Storia d’Italia, vol. 5, I documenti, t. 2, Einaudi, Torino 1973, pp. 1781-1828
7Nani Michele, Piccole storie di tessitori alle radici del movimento operaio, «il manifesto», 18 gennaio 2007
8Musso Stefano, «La storia del lavoro tra crisi e rilancio», in A. Verrocchio, E. Vezzosi (a cura di), Il lavoro cambia, Université de Trieste-Istituto Livio Saranz, Trieste, 2013, p. 23-37.
9Merli Stefano, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano 1880-1900, Firenze 1972.
10Thompson Edward P., Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra, traduzione di Bruno Maffi, Milano, 1969 (edizione originale inglese: Londra, V. Gollancz, 1964).
11Mendels Franklin F, «Proto-Industrialization: The First Phase of the Industrialization Process», The Journal of Economic History, vol. 32, no. 1, 1972, pp. 241–61.
12Kriedte Peter, Medick Hans e Schlumbohm Jürgen, L’industrializzazione prima dell’industrializzazione, Bologna, Il Mulino, 1984.
13Deyon Pierre, «L’enjeu des discussions autour du concept de ‘proto-industrialisation’», Revue du Nord, LXI, 1979, p. 9-15 e «Fécondités et limites du modèle proto-industriel: un premier bilan», Annales Economie Société Civilisation, 1984, n°5, p. 868-881.
14Benigno Luciana, «L’introduzione del telaio meccanico nell’industria laniera biellese e la formazione della classe operaia», tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Lettere, 1971.
15Bron Jean, Histoire du mouvement ouvrier, t. 1: Le droit à l’existence, du début du XIXe siècle à 1884, Paris, Les éditions sociales, 1968 ; t. II: la contestation du capitalisme par les ouvriers organisés, Paris, Les éditions sociales, 1970. T. III: La lutte des classes aujourd’hui (1950-1972), Paris, Les éditions sociales, 1973.
16Maitron Jean, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Paris, 1964-1997 (ormai in linea: maitron.fr)
17Perrot Michèle, Les ouvriers en grèves, 1871-1890, Paris-La Haye, Mouton, 1973.
18Terrier Didier, Les Deux Âges de la proto-industrie. Les tisserands des villages du Cambraisis et du Saint-Quentinois, 1730-1880, Édition de l’EHESS, Paris, 1996.
19Van der Linden Marcel, « Enjeux pour une histoire mondiale du travail », Le Mouvement social, 4, 2012, p. 3-29.
20De Vito Christian, Gerritsen Anne (a cura di), Micro-Spatial history of Global Labour, Basingstoke, Palgrave, 2017.
21Revel Jacques, «L’histoire au ras du sol», prefazione a Giovanni Levi, Le Pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1989, p. I-XXXIII.
